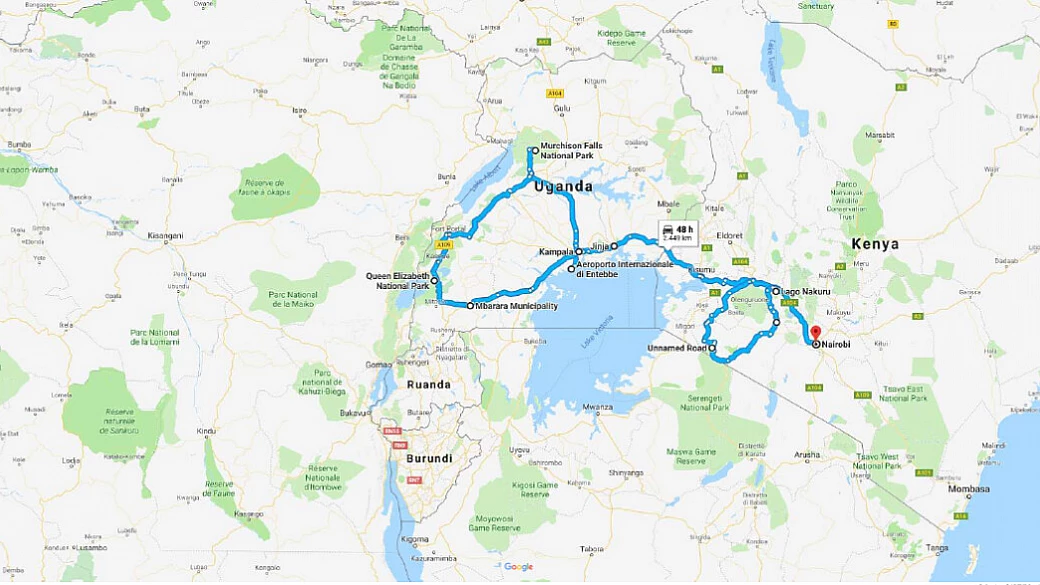Vademecum kenyota e riflessioni africane

MARE – Se andate in Kenya per il mare forse avete sbagliato meta. L’acqua non è inquinata ma i fiumi trasportano tonnellate di sabbia rossa; e le maree rendono il mare di fronte a molte spiagge quasi impraticabile (acqua bassa, ricci enormi), a meno che non si decida di allontanarsi molto dalla costa con escursioni a pagamento. Ha senso andare in Kenya con l’obiettivo di vedere la gente e la natura, per riposarsi sulla costa tra un’escursione l’altra. In ogni caso, è bene sapere che il mare più bello e raggiungibile si trova a Watamu.
SAFARI – Ne abbiamo fatti due. Uno di tre giorni in una concessione privata di 400 km quadrati confinante col parco nazionale dello Tsavo. Si chiama Lualenji Camp ) ed è gestito da un ex imprenditore italiano che vive in Kenya. Il vantaggio consiste nel fatto che non c’è la ressa di fuoristrada e pulmini che s’incontra nei parchi pubblici, si può circolare anche all’imbrunire e non ci sono piste vere e proprie, cosicché si vaga a proprio piacimento. Inoltre al Lualenji Camp (un campo con ottime tende ben ammobiliate e con wc) si mangia italiano (incredibile: tagliatelle fatte e ravioli fatti in casa, anzi in lodge…Tanto per capirci). Inoltre si viene accompagnati (è rarissimo) da uno degli ultimi affascinanti tracciatori, un anziano signore nero che un tempo accompagnava i cacciatori nei safari in stile Hemingway, grazie alla secolare tradizione della sua tribù). Per informazioni visitare il sito di Ugo (un gentilissimo e informatissimo italiano diventato “keniota” da 14 anni): www.Kenyacolors.Com. Potete anche scrivergli (kenyacolors@libero.It ) per chiedere informazioni su questo safari e altri, altrettanto originali, e per farvi aiutare a prenotare. In genere resort e agenzie propongono invece i safari normali nelle riserve pubbliche, che stanno a quello a Lualenji come una vacanza a Riccione sta ad una vacanza alle Eolie. I prezzi sono simili. L’altro nostro safari, di due giorni, in compagnia di Ugo, si è svolto sulle Shimba Hills ) e nel cosiddetto Santuario degli elefanti, una cinquantina di km a sud di Mombasa: mentre la savana è piatta, lì ci sono colline e fiumi, con tratti di foresta pluviale. Abbiamo dormito un albergo affascinantissimo, in legno, costruito tra gli alberi, sulle rive di uno stagno dove si recano molti animali (Shimba Rainforest Lodge, ( http://www.Africanmeccasafaris.Com/pdf/kenya/lodges/Shimba_Hills_Lodge.Pdf ) .
BEACH BOYS – Sono in genere disponibilissimi e simpaticissimi. “Abbordare” turisti sulla spiaggia è il loro lavoro. Quasi sempre propongono escursioni più economiche di quelle proposte nei villaggi turistici (a parità di qualità), ma lo fanno per conto di agenzie, quindi cercano di ottenere un buon margine di guadagno per loro proponendo all’inizio prezzi molto alti. Trattate, senza mancare loro di rispetto. In genere si riesce ad ottenere uno sconto di almeno il 30 % rispetto al prezzo proposto in origine. Fatevi raccontare le loro storie. E’ istruttivo. A Kikambala noi ci siamo “mischiati” quasi subito con loro, accogliendo gli inviti dei ragazzi che – tenuto a bada dai vigilantes, ragazzi come loro – ci facevano la corte sulla spiaggia libera. Parlavano solo inglese perché lì di italiani ne giungono pochi ma un loro amico-socio, Mark, originario di Malindi, lo parlava benino. Ci affidiamo a loro per la nostra trasferta a Mombasa, l’acquisto di frutta e pesce (abbiamo il cucinino nell’appartamento), la scelta di oggettini vari e dell’unico ristorante esterno al residence e raggiungibile a piedi. Sapevamo che su ogni nostro acquisto loro applicano un piccolo ricarico per guadagnarci qualcosa. Io ho detto loro che ne ero consapevole, loro hanno ammesso. Ma non mi è spiaciuto, anche perché nel minimarket del residence costava tutto come se fossimo stati in centro a Milano; e, soprattutto, perché non potevo pretendere di pagare un ananas 20 scellini (cioè venti centesimi di euro) e un mango 5 scelllini (5 centesimi) come se avessi il loro stesso tenore di vita. I ragazzi mi dicevano “Voi siete il nostro business”. Vero. Siamo diventati amici.
SAVANA – Arriviamo nella savana pensando ai documentari naturalistici che ci propina la nostra tv. Invece la savana è una sorta di oceano senza fonod in cui gli animali si mostrano con pudore. Sembra incredibile, ma per distinguere una mandria di bufali o un gruppo di elefanti ci vuole un occhio allenato (quello del tracciatore). Il fascino di questa esperienza è comunque indescrivibile. Ci sentiamo di tornare alle nostre radici. Sappiamo da dove partiamo ma l’orizzonte, laggiù, pare nasconderci i nostri sogni e le nostre paure ancestrali.
MOMBASA – E’ una città africana che vale la pena di visitare. Andare alla fabbrica del legno (10.0000 persone che a rotazione vi si recano per realizzare statuette di legno) e provare ad attraversare il piccolo braccio mare non dotato di ponti (Mombasa è su un’isola) con il ferry-boat , lungo la strada per la Tanzania. Si entra a contatto con lo stile di vita africano.
VILLAGGI – Visitateli. Magari sono a 200 metri dal vostro residence, celati dalla vegetazione. La gente vive per lo più in capanne di pietra e fango. Vederli, aiuta a renderci conto della distanza tra noi e loro. Siate gentili, non mettetevi a fare foto a tutto spiano come se foste allo zoo. E’ gente vera, dignitosa. E’ consigliabile farsi accompagnare in un’escursione sulle colline dell’entroterra, alle spalle della costa che unisce Mombasa e Malindi. C’è l’Africa genuina. Con i beach-boys di Kikambala abbiamo visitato il loro villaggio, nei palmeti attorno al residence. I più “fortunati”, come Mark, vivono in una delle stanze di casupole in muratura che in Europa useremmo come pollai e che qui sono già uno status symbol (l’affitto costa loro 10 euro al mese, una somma che spesso faticano a racimolare). Le famiglie un po’ meno fortunate stanno in baracche di lamiera costruite su un basamento di cemento. Le più povere – la maggior parte – vivono in capanne di fango, legno e sassi coperte da frasche. La vita sociale si svolge sulla terra battuta attorno alle capanne, dove si cucina su piccoli focolari, usando scatole di latta come pentole. Un pozzo con una pompa manuale regalata da uno turista tedesco fornisce l’acqua. Nel villaggio c’è anche una specie di pub, dove si serve una terribile (per noi…) bevanda alcolica ricavata dal latte di cocco. I nostri amici ci mostrano alcuni alberelli: sono piante di chinino, che servono per produrre decotti usati come medicinale – spesso l’unico abbordabile – contro la malaria; altre piante servono per tenere lontane le zanzare, altre per curare l’emicrania o l’otite. Non c’è arbusto che non serva a qualcosa. L’unica tv è in una capanna più grande: si paga per entrare. Nei pressi vivono tre coppie miste, più o meno benestanti, frutto di amori tra tedeschi, olandesi, svedesi e gente del posto.
SCUOLA – Il Kenya è uno dei paesi africani in cui si vive meglio, malgrado tutto. La scuola è obbligatoria per i primi anni e quasi gratuita per otto anni. I giovani parlano quasi tutti due lingue (inglese e swahili), il 95 % sa leggere e scrivere. In media, solo il 30 % dei kenioti è analfabeta. Le scuole sono a tempo pieno e i ragazzi hanno, a seconda dell’istituto, divise diverse (obbligatorie). Al mattino e nel tardo pomeriggio è tutto uno sciamare di bambini in divisa, che tornano nei loro villaggi a piedi, percorrendo anche decine di km.
RELIGIONE – Sulla costa il 30 % dei kenioti è di religione musulmana. In Kenya ci sono anche cristiani di tutti tipi (cattolici, pentecostali, battisti, valdesi, apostolici, ecc. Ecc.) come testimoniano le decine e decine di piccole chiese che si susseguono lungo le strade, alternandosi a qualche moschea. Ci sono anche molti animisti. Assistere, se si ha tempo, ad una funzione religiosa, tra canti e danze.
MALINDI – Malindi è una cittadina strana, dove vivono tantissimi europei (alcuni in pianta stabile), tra cui moltissimi italiani: certi sono fuggiti dall’Italia per motivi giudiziari, altri (la maggioranza) è giunta qui per gli effetti da “mal d’Africa”. Fatevi raccontare le storie degli italiani di Malindi. Roba da romanzo. Shopping: da Mulla, sotto i portici nei pressi della stazione di polizia, si comprano oggetti belli a prezzi interessanti, soprattutto se chiedete di visitare il sotterraneo (se si ha pazienza, si possono trovare oggetti di legno degni di un antiquario). Mangiare: ci siamo trovati benissimo nel piccolo ma romantico ristorante “Il vecchio e il mare” (ovvero, “The Old Man e the Sea”), sul lungomare; “Lorenzo’s”, nell’interno, offre raffinatissima cucina italiana con camerieri in guanti bianchi, in uno splendido parco, a prezzi da trattoria popolare milanese; vicino alla polizia c’è un ristorante indiano che offre sensazionali gamberoni.
MALARIA – Io mia moglie abbiamo seguito il consiglio datoci da italiani che vivono in Kenya da anni (e anche dalla nostra agenzia di viaggio). Mentre i vaccini per le altre malattie sono utili (sono efficaci per anni e non hanno controindicazioni significative), contro la malaria si fa in genere una profilassi preventiva, con farmaci molto dannosi per il fegato, fonte di malesseri vari, che non garantiscono di evitare la malattia. Cosicché è preferibile acquistare nelle farmacie keniote una confezione di farmaci specifici (introvabili in Italia) per bloccare la malaria sul nascere, appena se ne avvertono i sintomi (febbroni e forti dolori muscolari, incubazione max 60 giorni; si è certi di avere la malaria facendo un rapido test in qualsiasi ospedale). Ci si porta a casa la confezione (circa 5 $) e si sta tranquilli. In due giorni passa tutto. Contrarre la malaria per giunta è molto difficile. D’altra parte chi vive in Kenya da anni non potrebbe sobbarcarsi la comune profilassi antimalarica per sempre (anche perché ci lascerebbe le penne), quindi tutti – laggiù – si limitano a prendere le medicine citate in caso di necessità. Un nostro amico, in 14 anni di soggiorno in Kenya, ha preso la malaria tre volte. NB: là prendere la malaria è “normale” come beccarsi un raffreddore in Italia.
DOGANA – All’arrivo la polizia keniota controlla i bagagli e si perde molto tempo, a volte. Se ne perde ancor di più alla partenza, perché i doganieri sostengono che non si possono esportare le conchiglie (di cui invece le valigie sono colme), anche se nessuna guida turistica è dello stesso parere. In genere chiedono qualche euro o dollaro per far finta di niente, ammesso che qualche norma ponga davvero quel divieto.
VALUTA – Gli euro vanno benissimo (1 euro = 95 scellini). In dollari sono cambiati a 75 scellini l’uno. Le banche chiedono commissioni alte. I cambiavalute “clandestini” no. In genere sono persone per bene ma contate subito i soldi e, prima, contrattate sul cambio.
VISTI – Si possono ottenere anche a Fiumicino (stesso prezzo: 50 dollari o 40 euro), nei presi dei banchi del check-in. In teoria dovrebbero farvi risparmiare tempo in Kenya, invece non è stato così, almeno nel nostro caso. Comunque, nell’attesa, tanto vale anticipare il pagamento. Non si sa mai… In più accettato anche i vecchi dollari (quelli con la testa piccola), che in Kenya non vuole quasi nessuno.
SUPERMERCATI – Noi abbiamo avuto due residence i cui appartamenti erano dotati anche di cucinotto e quindi un po’ di spesa nei supermercati l’abbiamo fatta. Vicino a Mombasa c’è un supermercato ipertecnologico per bianchi e kenioti ricchi: Nakumat. C’è di tutto. A Malindi ci sono molti minimarket, compreso uno a gestione italiana. Nei mercati all’aperto in teoria è più conveniente comprare la frutta ma ai bianchi (forse giustamente) viene fatto pagare il triplo o il quadruplo del prezzo proposto ai neri. Morale: è più economico, per noi, Nakumat.
TRASPORTI: la gente del posto usa i matatu, di cui si dice che abbiano due marce: fermi o a tavoletta. Meglio usare i taxi. Contrattare sempre.
SOLE – Siamo all’equatore. Il sole scotta sempre, anche durante i safari !!! STRADE – Le poche strade asfaltate sono in genere classificate come autostrade (come la Mombasa-Nairobi e la Mombasa –Malindi), anche se sono larghe come una nostra strada di campagna e anche se spesso l’asfalto scompare tra buche e crepe. Le altre strade sono in terra battuta. Ogni venti o trenta km la polizia blocca parzialmente le strade con pezzi di lamiera contorta e irta di chiodi. A quanto pare, non fermano i turisti.
LINGUA – Con un minimo d’inglese si tira avanti ovunque. A Malindi parlano quasi tutti anche l’italiano. Lo swahili è affascinante ma incomprensibile.
RESIDENCE – Il nostro primo residence è a Kikambala, 25 km a nord di Mombasa: è basato sul sistema delle multiproprietà, vi giunge solo che possiede qui o altrove (in base al sistema dello scambio, è il nostro caso) appartamenti analoghi. Nei pressi c’è un vecchio villaggio turistico molto economico e cadente, usato dai professionisti kenioti per svolgere meeting commerciali (lo visitiamo, la piscina sembra una palude, ma per il resto non appare malaccio); c’è anche un altro villaggio per turisti africani (strano ma vero): in quei giorni c’era una comitiva di ugandesi. Il nostro residence è isolatissimo ed è gestito da indiani (la minoranza – giunta più di un secolo fa con i britannici per costruire le ferrovia Mombasa-Kampala, in Uganda – che ha in pugno le leve del commercio in Kenya); è “popolato” soprattutto da inglesi, veri professionisti nella capacità di non “mischiarsi” con la popolazione nera. L’altro residence è il Mweembe, gestione italiana, a Malindi: è in grande e splendido parco con ville e villette appartenuto ad un ricco italiano rovinato dal gioco d’azzardo nel casinò locale. Il Mweembe ospita il raffinato ristorante Lorenzo’s. BARRIERA CORALLINA – A Kikambala i beach-boys ci accompagnano a passeggio sulla barriera corallina, durante la bassa marea che prosciuga il mare facendo calare l’acqua di cinque o sei metri due volte al giorno. E’ una faticaccia camminare, malgrado l’acqua bassissima, ma loro mi tengono per mano, mi offrono un bastone per reggermi e anche un paio di vecchie ciabatte molto più robuste delle mie italianissime ma fragili scarpe di gomma da scoglio: ci sono conchiglie che sporgono dalla sabbia affilate come rasoi, ricchi tropicali con spine lunghe dieci centimetri. Incontro un omino che raccoglie coniglie per venderle ai turisti. Una sfacchinata interessante… ———————————————- RIFLESSIONI Ogni volta che visito un posto nuovo non posso fare a meno di cercare di capire coloro che ci vivono e di valutare il modo in cui io “vivo” loro. In questa occasione ho capito soprattutto una cosa: il Kenya non si vergogna. Si mostra così com’è: povero, aggrappato alla vita, in fermento, impegnato a galleggiare sulla suo destino, così diverso dal nostro.
Siamo noi “bianchi” che ci vergogniamo, più o meno consapevolmente, dell’opulenza in cui, rispetto alla 90 % di loro, viviamo, anche quando, a casa nostra, ci sentiamo “poveri”. Per noi, soprattutto se è la prima volta che visitiamo un paese davvero del Terzo Mondo, il Kenya è dunque sconvolgente, per il bello e il brutto che ci mostra; non è così per loro, i “neri”, che hanno altro (per noi arduo capire cosa sia questo “altro”) cui pensare e per i quali siamo dei “diversi”, almeno quanto loro lo sono per noi. Penso che sia così tutta l’Africa, ma io ho conosciuto la “mia” Africa, per la prima volta, attraverso questo sua porta d’ingresso principale, tutto sommato la più “normale”: quella attraverso la quale giungono in questo complesso continente la maggior parte dei turisti.
Ognuno di noi si porta dentro, magari senza accorgersene, un pezzettino di Africa, quella dei nostri lontanissimi progenitori che lì hanno mosso i primi passi: quei paesaggi, quella gente e quella natura credo che evochino una sorta di “dejà vu”, forse quella sensazione che dalle nostre parti chiamiamo romanticamente “mal d’Africa”.
Così, se abbiamo occhi per guardare e qualche neurone sgombro per valutare, ci troviamo a mettere a confronto il nostro modello mentale di Africa con la realtà. Mi pare che, nel nostro mondo, si abbia un’immagine stereotipata di quel continete: lì, appunto, ci sono le nostre radici ma anche le nostre paure; sappiamo che da lì veniamo e che lì potremmo tornare; quegli uomini e quelle donne, così vivi ma così distanti, ci affascinano ma pure ci respingono.
I più “timorosi” di noi non usciranno più di tanto dai villaggi turistici e l’Africa sfilerà loro accanto come in un asettico documentario, senza lasciarsi alle spalle vere sensazioni. I più “coraggiosi” – o “sensibili” – cercheranno di capirci qualcosa, anche se presto dovranno ammettere che – al di là delle sensazioni superficiali, degli approcci amichevoli con la gente – i nostri mondi sono così distanti da rendere difficile la creazione di veri canali di comunicazione, come se trasmettessimo su frequenze simili ma differenti. Ecco, siamo diversi: non lo affermo in senso razzistico, intendo affermare che noi adottiamo linguaggi mentali diversi dai loro per rappresentare esigenze e aspettative non sovrapponibili. D’altra parte, senza andare lontano, è già difficile “mettere in comunicazione” lo stlle di vita di un italiano sudtirolese con quello di un pescatore di Mazara del Vallo, le mentalità di un napoletano con quella di un triestino. Dunque, come far comprendere davvero ad un kenyota i nostri problemi (tipo: la depressione, lo stress da competizione, l’invidia per la ricchezza altrui, le rate da pagare, la rabbia per non poter comprare la seconda casa che sogniamo, le liste d’attesa per un’esame clinico e via elencando) quando in Kenya, dove già si campa decorosamente rispetto al resto dell’Africa, ci si confronta non con l’esigenza di vivere bene, secondo la nostra concezione occidentale, ma con l’istinto di sopravvivenza? Perché, ad esempio, l’acqua potabile è un lusso riservato ad un élite. Perché con un reddito medio di 30 o 40 euro al mese (quando si è fortunati) è difficile comprare anche l’aspirina, non parliamo dei farmaci per curare la comunissima malaria. Perché si abita spesso in case fatte di fango, legno e sassi, magari celate dalle palme a duecento metri dai nostri residence e villaggi turistici. La tv nazionale propone quesiti tipo: “E’ giusto che la ferrovie kenyote siano ritenute responsabili dei danni subiti da coloro che viaggiano aggrappati esternamente ai vagono o sui tetti delle caroozzze?” (poco prima aveva mostrato un tale caduto sui binari e rimasto senza un braccio). In compenso quasi tutti parlano due lingue (inglese swahili), alcuni tre (francese o italiano). Il 95 dei bambini va a scuola per otto anni, solo il 70 % della popolazione è analfabeta.
Certo, anche noi abbiamo difficoltà a capire davvero quali sono i loro problemi, al di là della compassione o della solidarietà che in qualcuno di noi sorgono spontanee. E non è questione di valutare qual è la cultura migliore; semplicemente “respiriamo” flussi di pensieri differenti, che raramente s’intersecano davvero. C’intendiamo, guarda caso, sui bisogni materiali spiccioli: la mancia, la maglietta regalata, le penne donate, la mano che ti offrono per non farti scivolare quando ti accompagnano a passeggio sulla barriera corallina o nella savana. Per il resto, si avanza a tentoni. Cambiano i punti di riferimento. E noi siamo marziani, col nostro respiratore che ci rifila certezze importate fresche fresche dalla mondo occidentale, dalla sua tv, dai suoi libri di suola, dalle sue chiese, dalle sue guide comprate nella libreria del centro. Tanti suggeriscono di portare con sé vecchie magliette, caramelle e penne da donare ai bambini. L’abbiamo fatto anche noi ma l’esperienza mi ha lasciato l’amaro in bocca. Quelle caramelle, quelle magliette, quei quattro spiccioli che doniamo servono soprattutto per gratificare noi stessi. Non dico che lo facciamo in cattiva fede. Però laggiù siamo portati a recitare la parte di “quelli che sono in Africa e devono sentirsi buoni”. Così facciamo in Kenya quello che non ci sogniamo quasi mai di fare con i nostri nomadi assiepati in campi privi di ogni riosorsa, con i nostri poveri, con i nostri barboni e via elencando. Per giunta, lo facciamo in aree molto limitate (Mombasa, Malindi, la costa insomma), quelle in cui si concentrano il 90 % dei turisti, dove tutto sommato si vive un po’ meglio proprio grazie al turismo. Insomma, parrà assurdo: ma il Kenya è la Svizzera d’Africa, tanto è vero che moltissimi europei vi si trasferiscono.
Però la miseria si vede (almeno, la miseria secondo il metro di noi “bianchi”). Che fare? In una guida dedicata al “turismo responsabile” ho letto che non bisogna abituare quei bambini e quegli adulti all’accattonaggio, perché imparare ad essere padroni del proprio destino è tutta un’altra questione. Ne ho parlato anche con Ugo, un italiano che vive a Malindi da 14 anni per amore dell’Africa (ha un sito internet, www.Kenyacolors.Com , molto interessante e utile) ma che, proprio grazie alla sua lunga permanenza in Kenya riesce a vedere tutto da un punto di vista più maturo del mio. Col senno di poi, condivido questa valutazione. Penso che non dovremmo neppure scendere a patti con nostro bisogno di apparire compassionevoli, magari solo per una settimana o due all’anno, quasi che in Africa fosse un’esperienza obbligatoria, come comprare le statuine di legno da portare ad amici e parenti. Mi sono convinto del fatto che sarebbe meglio, e meno ipocrita, dedicare un po’ dei nostri soldi, anche pochi, ai progetti portati avanti da organizzazioni religiose e laiche che vogliono rispondere ai bisogni primari e reali di quelle persone, anche di quelle che non hanno mai visto un turista “compassionevole” in vita. E poi possiamo fare del bene a loro e pure a noi cercando di parlare con loro, provando a capire qualcosa di più, rispettando la loro cultura ma prendendo pure coscienza dei loro limiti. Coltivare il mito del “buon selvaggio”, ad uso e consumo della nostra vacanza più o meno breve, non è giusto. Né per loro, che devono poter credere nelle proprie forze. Né per noi, che non dovremmo continuare a nascondere la testa nelle nostre certezze.