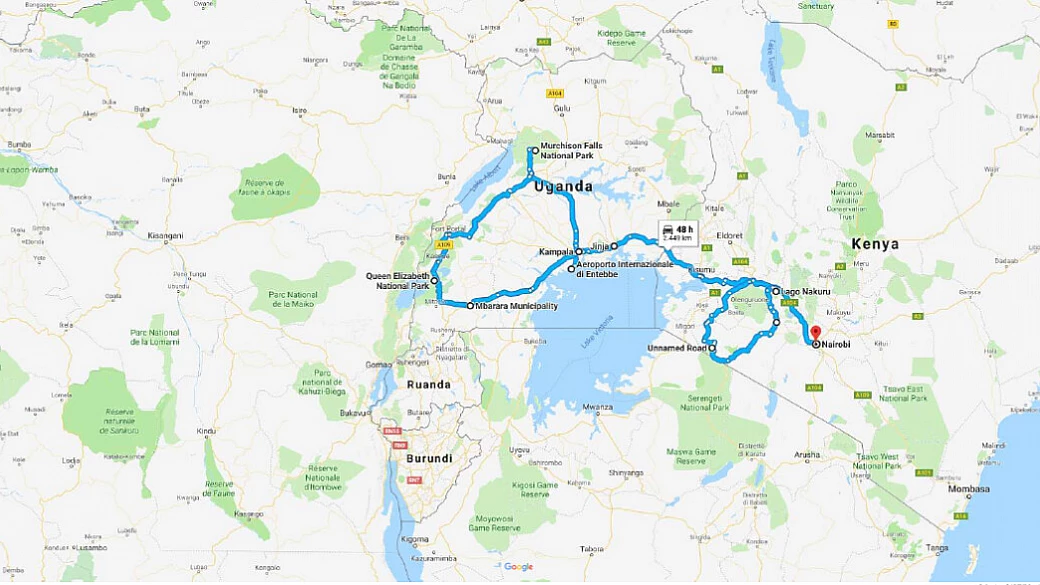Cronache di uomini e bestie dall’Africa quotidiana

Le scolopendre sembravano smarties incollati uno sull’altro o tutte rigorosamente nere o tutte rigorosamente rosa e sull’ultimo smartie due antennine, per indicare al regno animale che lì era ubicata la testa e non il culo dell’insetto. Erano entrambe mortali. La differenza è che quella nera lo era ovunque ti mordesse, quella rosa era più selettiva e lo diventava solo se le permettevi di morderti alla gola o in altri punti che non rammento più.
Una mattina feci la doccia nel bagno grande. Era in realtà una vasca sormontata da un’inutile e tristissima tendina di plastica, di un beige ‘Europa dell’Est prima della caduta del muro’ con un’asta a un metro e cinquanta per fissare il tubo della doccia che mi costringeva sempre a lavarmi ingobbito. Quella mattina non so chi, se Dio, Maometto, Buddha o lo sciamano del giardiniere, mi fece tenere gli occhi sempre puntati sul troppopieno della vasca. Non appena l’acqua scrosciò, una scolopendra nera colta dal panico sbucò fuori dal troppopieno. Si spostava rapidissima ed era a trenta centimentri dal mio piede. Senza pensarci due volte, diedi una spallata alla tendina cascando rovinosamente sul pavimento. Mi rialzai a fatica, afferrai uno zoccolo e colpii la scolopendra. La colpii, la colpii, la colpii, la colpii… e anche quando ormai era solo una gelatina nera, io continuai. Mi ci vollero un paio di giorni per smaltire lo choc.
Gli scorpioni avevano una bizzarra predilezione per l’ingresso dell’unica farmacia di Malindi. Ogni volta che dalla porta a vetri vedevo i clienti disposti a coda di pavone – tutti ai lati, nessuno al centro – capivo che lo scorpione era arrivato. Nessuno si prendeva la briga di calpestarlo. Soprattutto gli inglesi. Per loro uno scorpione all’ingresso della farmacia era la cosa più naturale di questo mondo come Dio che salva la Regina nell’inno nazionale, come il malto nella birra, o la salsa di menta sull’agnello. Facevano la fila per il chinino e ogni tanto buttavano un’occhiata più seccata che preoccupata al pavimento. E lo scorpione col pungiglione sollevato finiva sempre a nascondersi dietro ai barattoli di latte in polvere della Mellin.
Il Nairobi eye, l’occhio di Nairobi, è un insetto che sembra nato da una un’anatema di Osama Bin Laden. Quando si posava su un volto, su una schiena o su un torace, lasciava una scia, come le bave delle lumache, una scia urticante che procurava ustioni di secondo grado. Un militare della base San Marco, in Kenya solo da una settimana, era tormentato da uno di questi insetti. Da quando aveva iniziato a parlarmi, non gli dava requie; gli volava sul petto villoso, con una predilezione feticistica per i suoi capezzoli color rene. Il militare provò un grandissimo piacere a ucciderlo. Se lo spiaccicò sul petto col palmo della mano aperto e se lo sfregò con un massaggio circolare su tutto il petto. La sera lo portammo dallo sceriffo, il sarto somalo della piazzetta. Urlava, aveva il petto in fiamme, bolle enormi che partivano dai capezzoli e arrivavano all’ombelico. Lo sceriffo sterilizzò un ago lungo come una candela e con quello gli bucò le bolle.
Quando si appendevano i boxer occorreva fare attenzione. Ci sono mosche che depongono le uova nella biancheria intima. A Pekesce il nostro giardiniere le uova le deposero sotto alle unghie delle mani. Quando iniziarono crescere Pekesce impazzì. Si ubriacò col pombe, una birra ad altissima gradazione alcolica che puzza come la carogna di un cane, accese un falò e ci buttò dentro le mani. Restò a letto per un mese. Due delle quattro mogli lo piantarono. Scoprimmo che aveva chiesto ai loro genitori di ‘rateizzargli’ il pagamento delle doti; adesso che lo vedevano a letto, febbricitante e con le mani fasciate, erano convinti che non avrebbe più onorato il debito. E così per colpa delle mosche, Pekesce perse metà del suo harem…
Ci alzavamo con la luce del sole e facevamo colazione in veranda. Il latte lo vendevano in buste di plastica, come quelle della mozzarella, ed era razionato. Ne concedevano una sola per famiglia. Quel latte era di una bontà sconvolgente. Sebbene lo mungessero da vacche magrissime, quasi scarnificate, era un vero champagne caseario che nessun latte svizzero avrebbe eguagliato. Mamma riempiva la tavola di frutta. La papaya non piaceva a nessuno, nemmeno a lei che la riciclava nelle marmellate. Per il mango invece, avevamo tutti un’adorazione. Mamma si prendeva sempre l’osso. Papà mangiava la testa dei pesci, mamma impazziva per l’osso dei manghi. E mentre facevamo colazione, guardavamo i corvi planare sulle buganvillee e ammassarsi sui rami come a una riunione di condominio.
Pekesce tagliava l’erba con le sue magrissime gambe infantili e con una buffa bandana da premier che gli fasciava la testa. Ogni tanto qualcuno si avvicinava al cancello facendo dondolare una sporta di vimini. A volte erano venditori di cocchi acerbi, fantastici da bere nell’ora più calda, a volte pescatori di gamberi di fiume, a volte di granchi. Quei granchi avevano qualcosa di preistorico, pescati invece che dal mare dalle pagine più ardite di H.G.Wells: le loro chele studiavano l’avversario con movimenti lenti e circolari, poi all’improvviso ti attaccavano con affondi isterici, quasi con mosse da kung fu, che potevano farti parecchio male, visto le dimensioni delle chele. Quando i venditori bussavano alla nostra porta, glieli compravamo tutti.
Fuori dalla casa, avevamo un grosso lavandino che usavamo per lavare i panni. Kaindi li rovesciava lì dentro. Ma ogni tanto qualche granchio evadeva dal lavandino e subito gli altri lo imitavano, così, all’improvviso, ci trovavamo il soggiorno allagato da una chiazza arancione, decine di granchi con le chele sollevate che pizzicavano rabbiosamente l’aria. Ho letto qualcosa di simile in Chatwin, su un’isola della Svezia centrale, quando si ritrovò il soggiorno invaso da centocinquanta gamberi vivi come la risata di un bimbo e tutti imbrattati di aneto. Ma i granchi sono un’altra storia.
Una sera giocavamo tutti in sala a scala quaranta. Mia madre andò in cucina a prendere da bere. La vidi allontanarsi con la coda dell’occhio, poi la sentì urlare. Un attimo dopo la sala fu invasa da uno sciame di vespe. Volavano a centinaia, enormi, gli addomi gonfi e lunghi come i baccelli dei fagioli. Ficcammo tutti la testa sotto al tavolo, io mi coprì la testa con le braccia, mentre la sala ronzava come una piaga biblica. Poi mamma rientrò seguita da Kaindi. Avanzava impavida con un asciugamano sul volto, sparando DDT alla cieca, dappertutto. La battaglia durò qualche minuto, nel frattempo Kaindi spalancò una finestra: quelle che non fuggirono, caddero morte sul pavimento. Erano un’esagerazione. Kaindi le scopò via e ci fece tre cumuli e quando mamma prese la paletta per gettarle nella spazzatura Kaindi la fermò con un sorriso. Se ne andò a casa sua con le vespe avvelenate e qualche giorno dopo quando mamma gli chiese che ne aveva fatto, le sorrise come un gatto. “Erano buonissime” e mentre mamma faceva roteare i suoi occhi divertita, lui le raccontò che nell’ugali, (la loro polenta bianca) quelle vespe erano state ‘impareggiabili’…
Mamma in Africa camminava sempre scalza. Un giorno andando a casa dei vicini per poco non mise un piede su un mamba; mamba in swahili significa coccodrillo, perciò hanno chiamato ‘coccodrillo’ un serpente. Bizzarro. Come chiamare dobermann un criceto. Il mamba è un elegantissimo stiletto di due metri che nell’erba alta quasi vola. Uno schiocco di frusta che solo a immaginarlo gela il sangue. Mamma lo vide sgusciar via e trovare asilo sui rami di un albero. Cacciò un urlo. I vicini accorsero. In un batter d’occhio sotto all’albero si scatenò un’allegra ressa da barbecue. I toscani in braghette erano i più eccitati, picchiavano il tronco dell’albero con i bastoni “O grullo d’un mamba” urlavano, mentre le signore di Brescia, dietro, abbondanti nel loro pareo, distribuivano a tutti Martini bianco nei bicchierini di plastica del caffè. Una signora di Como si fece largo con un binocolino da teatro. Si mise a spiare il fogliame e a dare il tempo ai ‘percussionisti’ toscani. Spuntò persino una tromba da stadio che assordò tutti, tranne il mamba. Il cuoco che la portò fu allontanato a male parole. Un fotografo di Focette fece rotolare un copertone fino alla base del tronco .Disse che andava bruciato “Ai serpenti il fumo dà noia… date retta a me”. Sembrò a tutti un’idea geniale: ma quando bruciò, il copertone appestò l’aria di un fumo nero e catramoso. Tossirono tutti , tutti, tranne il mamba, che nemmeno il binocolino riusciva più a individuare nel fogliame.
Da una casa vicina corse voce che la Fiorentina aveva iniziato a giocare – la domenica i toscani si davano appuntamento nella piscina di Camillo Duranti e ascoltavano le radiocronache delle partite dall’Italia. Il mamba di colpo non interessò più a nessuno. La ressa si sciolse e ognuno andò per i casi suoi. Mamma raccolse da terra i bicchierini di plastica e chiamò Kaindi. Gli disse di spegnere quel fuoco oleoso. Le signore avevano scolato la bottiglia del Martini e l’avevano dimenticata nell’erba. Quando mamma si chinò a raccoglierla, sentì l’aria spostarsi intorno a lei; era come uno schiocco di frusta, che le bagnò di sudore la fronte. Si voltò e vide Kaindi impietrito. Stava quasi sull’attenti con le pupille allucinate, la panga rigida su un fianco e le labbra serrate. Mamma non chiese niente. Prese la bottiglia, si alzò e riprese a camminare scalza. Ora che il mamba se ne era andato, le veniva quasi voglia di cantare…
La mattina uscivo di casa presto e andavo a fare lunghe passeggiate sulla spiaggia. Avevo due alternative: o raggiungere il porto, oltrepassare il Fish Market, farmi poi a piedi nudi un lungo tratto d’asfalto arroventato e ritrovare la spiaggia all’altezza di Casuarina o tirar dritto per la parte opposta e arrivare alla foce del fiume Sabaki. La foce era immensa e pullulava di uccelli come una voliera.
Mi divertivano i pellicani con quel loro becco da avanspettacolo, con quella loro pappagorgia del sacco dilatabile. Erano i più lesti coi gabbiani a correre incontro ai pescatori. I pescatori portavano a riva le loro elementari piroghe. Non tornavano mai a mani vuote, ma il pesce era sempre poco, di piccolo taglio e nemmeno così bello da vedere. Pesci da terzo mondo per pescatori da terzo mondo. Nella scala gerarchica dei giriama, i pescatori erano i paria. Di un popolo già povero, loro erano i più poveri, gli unici a non venir mai a contatto coi turisti, perché pescavano lontano dagli hotel e perché se un turista gli avesse rivolto la parola anche solo per sapere com’era andata la pesca sarebbero rimasti muti perché per loro l’inglese era un oceano in cui non sapevano navigare. Piccoli, neri, malnutriti, i capelli scuri e crespi, le facce senza età.
Un giorno alla foce vidi uno di loro che litigava con un poliziotto. Il poliziotto era alto e portava scarpe d’un paio di numeri più larghe. Ed era un corrotto e untuoso figlio di puttana, di quelli che ti fanno un favore all’aereoporto e la sera dopo ti vengono a bussare a casa perché del grazie del giorno prima non sanno che farsene. Il piccolo pescatore aveva un fusto di greggio vuoto che usava per pescare. Il poliziotto corrotto glielo stava portando via per suonarci in una steel band. “Se vuoi proprio quello, pagamelo, così me ne compro un altro”. Il poliziotto non ne voleva sapere “Tu l’hai rubato al mare. Tu al mare non l’hai pagato e allora perché io dovrei pagarlo a te?” La lite degenerò. Non parlavano in swahili, ma in dialetto giriama. Il dialetto giriama non era poi così diverso, molte parole si assomigliavano, così io li ascoltavo litigare e capivo, non capivo tutte le parole, ma afferravo il senso della disputa. E la loro gestualità mi aiutava. Alla fine il poliziotto si spazientì e lo afferrò per un braccio. Gli disse che se avesse continuato a strillare lo avrebbe portato alla special branch e lo avrebbe fatto sbattere in una cella.
A quel punto intervenni. Il pescatore era quasi in lacrime. Dissi al poliziotto – in inglese – che se non l’avesse lasciato in pace, alla special branch avrei portato lui, e al pescatore – in uno swahili misto a giriama – di stare tranquillo che nessuno gli avrebbe preso il suo fusto. Mi guardarono ammutoliti: bianchi che parlavano in swahili ce n’erano, ma che parlassero in giriama, era davvero una rarità. Il poliziotto si scusò con un sorriso – troppo largo come le sue scarpe – e se ne andò, il pescatore, invece, si mise a saltellare davanti a me, felice e incredulo. E iniziò a ringraziarmi in giriama. Non sapeva se essere più felice per il fusto salvato o per il fatto che per la prima volta potesse parlare con un bianco. Purtroppo il mio magico potere di interpretare il giriama si esaurì e mi toccò passare il resto della mattinata con quel piccoletto che saltellava davanti a me come un ossesso, arrabbiatissimo, perché di colpo non lo comprendevo più…