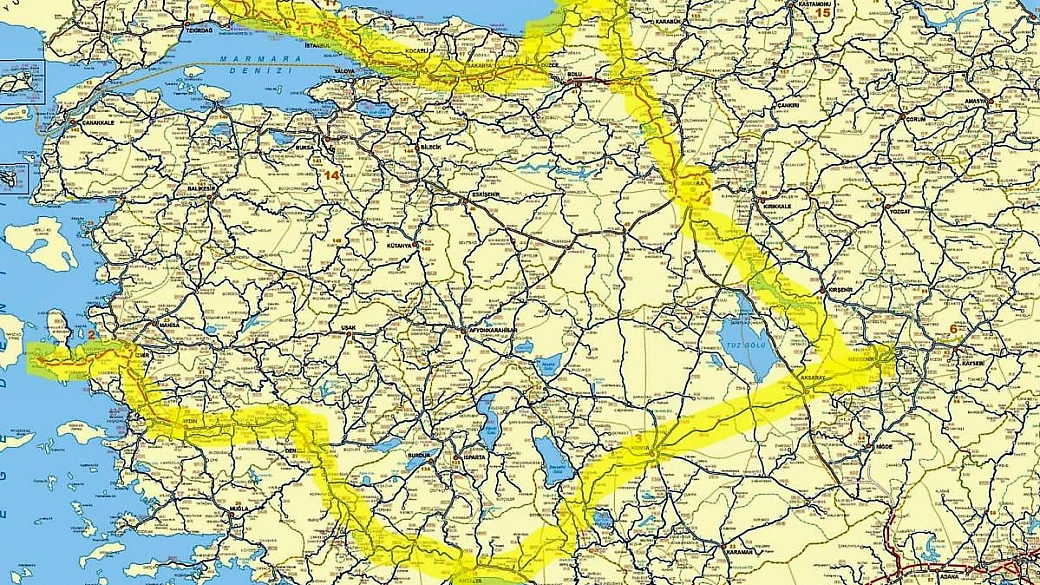Vicini, vicini

Mi risveglio al mattino e mi dico che son felice di fare questo viaggio. E quella costa alta sul mare? “Albània”, dice con un filo di incertezza il cameriere che la sera prima, a corto di acqua compresa nel prezzo, aveva fatto il giro dei tavoli versando un po’ della nostra ora agli uni, ora agli altri. “Albània”, ripete ora più deciso, annuendo anche col capo. Il colpo d’occhio dal ponte sul porto di Igoumenitsa è bello anche per chi viaggia spesso in mare. Ma questo sembra un lago. Il viaggio comincia con tutti i crismi: bel tempo, buona compagnia, preoccupazioni lasciate non ricordo dove. Non ho pagato il biglietto per loro. Incontriamo la nostra guida, Elena che, messo piede sul pullman, comincia i suoi racconti, che dureranno giorni, tra storia, leggende e mitologia, entrando in estasi. Parla con pathos, chiudendo gli occhi, rivedendo forse dentro di sé accadere i fatti di cui ci fa partecipi: la storia della signora Frosini gettata nel lago di Ioánnina dal capriccio di Ali Pasha, pazzo di un amore non corrisposto; o della donna ingannata dal marito che, vedendo crollare di continuo il ponte che stava costruendo nell’Epiro … Ho perso un pezzo, il filo. Quando mi riconnetto, la donna è diventata ponte e, pur vedendo vicina la sua morte, è felice di sapere che da lì un giorno potrà passare suo fratello, da troppo tempo lontano dalla patria.
Mentre Elena parla osservo il paesaggio che ci corre di fianco. Di cosa vivrà la gente qui? La vegetazione cresce spontanea, a caso, tra una roccia e l’altra, bassa e asciutta. Case rade (ma dov’è la gente?), qualche grosso uccello e poi alveari su alveari, una quantità straordinaria di cassette colorate, giocattoli ai margini della strada. Che sapore avrà quel miele? Di smog? Macchè, qui non passa anima viva! E il sospetto è confermato da strade strette che dimostrano scarso traffico, strade su cui possono fare la siesta anche greggi di capre. Il guaio è quando in tutte queste curve si incontrano due mezzi pesanti o lunghi: o con l’animo in pace ti predisponi ad arrivare ancora più tardi del previsto, o tiri fuori l’incoscienza e sorpassi alla cieca, sperando che qualche divinità ti assista. Marco, l’autista, guida come se stesse scivolando sull’olio; più tardi mi prende in giro perché dal monitor ha visto che per un tratto mi sono addormentata. Gli dico che così mi mette in soggezione e che non avrò più il coraggio di appisolarmi. Mi rincuora, strizzando un occhio “Dormi, dormi pure, che ci penso io a guidare.” È sempre bello sapere che c’è qualcuno che pensa a fare le cose per te. Gli alveari sono già miele per la mia curiosità; è come se tutte le api del mondo si fossero date appuntamento qui, un convegno laborioso, un raduno al buio in quelle cellette in cui ognuna sa cosa deve fare. Lascio volentieri, ancora una volta, che facciano il loro lavoro e ne assaporo più tardi il risultato nei dolci che ovunque ci fanno assaggiare.
Improvvisamente Elena cambia registro, comincia a parlare delle icone bizantine, poco fisiche, molto spirituali perché la pittura deve arrivare agli occhi di Dio. Siamo diretti alle Meteore. Dopo ore di strada, racconti e risate con i miei compagni di viaggio, il paesaggio da aspro si veste d’imponenza. Le rocce diventano padrone indiscusse. Sembra lo scenario di un kolossal (qui in effetti è stato girato uno dei tanti rocamboleschi 007); questi spuntoni di roccia, scolpiti contro un cielo di vetro, solenni bucano l’aria; hanno l’apparenza di cartapesta, esuberanti e seri faraglioni su un mare sparito da millenni, sulle cui cime sono cresciute costruzioni che confinano col vuoto, col niente e col tutto. Pietra su roccia, dentro la roccia, monasteri cementati alla terra con lo sguardo fisso al cielo. Leggo da qualche parte, su uno dei pochi foglietti che riportano una scritta in italiano, “Meteore: dove Dio sfiora le rocce” e credo sia più vero il contrario.
Scendiamo per salire al Grande Meteoro, quello della Trasfigurazione o Metamorfosi come dicono loro che di metamorfosi hanno le storie piene. Sembra di essere sul tetto del mondo senza provare la minima vertigine. Viene da abbracciare con l’animo quest’infinito di cielo e pietra, ed è straordinario capire che è possibile: si rischia però di sentirsi onnipotenti.
La sera, dalla mia camera d’albergo a Kalambaka, colgo meglio il significato del nome Meteore attribuito a questi monasteri bizantini. Se qui molte cose sono ora lasciate tristemente al caso, l’etimologia e la toponomastica hanno una loro precisa ragione d’essere: nel buio diffuso, da lontano, scorgo luci che si direbbero sospese nell’aria ma che, ormai lo so, nascono dalla terra.
A Kalambaka ho trovato le kombolóï, le coloratissime “perle dell’ansia”, da sgranare e giocarci per stemperare i cattivi pensieri: le cercavo ma qui, dove nascono, non mi serviranno affatto.
Ci svegliamo con la nebbia: d’altronde ci attendono le pianure della Tessaglia e della Grecia centrale ricoperte di piante di cotone. Da lì la nebbia prende vita. Campi sterminati di pianticelle brune e batuffoli bianchi. Solo Françoise riesce a portarsene via un po’, agli altri resta il ricordo.
Corriamo incontro all’archeologia, verso Delfi col Tempio di Apollo e quello di Atena Pronaia ai suoi piedi che vediamo lontano. Elena ne approfitta per ricordarci la favolosa nascita di Atena e la sua straordinaria amicizia con Pallade la cui morte gettò nello sconforto la dea al punto che volle costruire per sé una bambola in tutto identica all’amica perduta. Sulla storia di Pallade Atena si sofferma anche Roberto Calasso nel suo libro “Le nozze di Cadmo e Armonia”. Vado a ripescarlo con la mente nella mia libreria. Ce l’ho da anni: credo sia arrivato il momento di aprirlo.
“Là, dietro la nebbia, c’è il Monte Olimpo.” Perché proprio oggi ci è vietato anche scorgerlo soltanto? Non vedo il monte degli dei, ma immagino Zeus indaffarato con le sue imprese e i suoi amori, la bella Afrodite, la saggia Atena, Era gelosa e Dioniso pieno d’ebbrezza. A Delfi, ci avvisa Elena, ci si innamora.
Sono felice di arrivare al Tempio di Apollo, soprattutto dopo aver attraversato di fretta e a gomitate il Museo. Ho scoperto che l’archeologia ingabbiata e messa sotto i riflettori quasi quasi mi rattrista. Non è concesso il minimo contatto con queste storie messe in mostra. I racconti di Elena saranno pur coinvolgenti e accattivanti, soprattutto quando alle parole piene d’enfasi e d’amore per la sua terra si accompagnano ampi gesti delle braccia che danno più forza alle sue storie. Ma è continuamente interrotta da militareschi “No flash, please!”, o dalle voci di altre guide e di altre lingue che spintonano per trovare posto nell’etere. A questi spintoni incorporei si aggiungono quelli fisici di turisti dotati per lo più di curiosità fotografica per l’ombelico del mondo. “No flash, please!” All’aria aperta sto meglio, tra i ruderi del tempio ancora di più. Lì la storia è ancora viva, sembra di sentire l’oracolo e le sue risposte sibilline, si passeggia laddove la gente ha passeggiato, si va al teatro dove sono rimaste le tragedie di Eschilo, Sofocle, Euripide. “Quei monti sono la continuazione del Parnaso”. Ci sentiamo ricompensati dalla mancata vista dell’Olimpo, suo fratello maggiore. Qui le foto possono sprecarsi, senza bisogno di flash, senza che qualcuno impedisca qualcosa.
Un filo lega Delfi ad Atene, la trama di una rete che a lungo ha resistito. Ma ora? La visita all’Acropoli dovrebbe non comprendere la vista sui tetti della città. Ho provato disagio, una sera dopo cena, a passeggiare tra un’umanità degradata come le strade in cui vive. Un odore nauseante che impregna aria e marciapiedi dove restano i coriandoli di uno squallido carnevale. Odore di vita randagia, molto più di quella dei cani che abitano le vie e si vendono al miglior offerente per due coccole e un pezzo di pane. È questa l’Atene che ho immaginato? Cosa è rimasto dell’armonia che credevo fosse nata qui? Ce lo spiegherà Elena più tardi , quando i suoi racconti toccheranno la nota dolente della dittatura militare, che si guardò bene dal preservare la storia e osò di più: cancellarla, abbattendola insieme a straordinari palazzi, per far posto a casermoni uniformi che appiattirono, abbruttendolo, il paesaggio urbano. La città crebbe senza un piano regolatore, scatola fianco a scatola, un domino scombinato, grigio del colore dell’uniformità. Con impianti industriali tossici lo scempio raggiunse la campagna dove scorreva il fiume Cefiso, dove correvano madre e figlia (Demetra e Persefone?). Già rimpiango la passeggiata della sera prima a Kalambaka, tranquilla, sicura con le Meteore a proteggerne le giornate e pronte ad accendere e abbassare gli occhi per sorvegliare le sue notti.
Quella sera a Kalambaka avevamo chiesto “due coffee e un succo di frutta alla pesca”. Il barman, seccato per la nostra scarsa predisposizione all’inglese, pur avendo capito perfettamente, ci aveva quasi costretto a ripetere la nostra richiesta, su cui abbiamo riso e arrancato strafalcioni. “Juice. Peach.”, ci ha corretti scandendo deciso e acido le parole. Sembrava un’intimidazione, come a non perdonarci di essere italiani. Mi sembrava anche l’accoglienza peggiore che una terra può riservare ai turisti. Fuori dal bar l’avevamo però già dimenticato. L’Acropoli e il Partenone valgono comunque più di tutti questi inconvenienti. Giunti lì, tra noi e ogni bruttura si crea un’insormontabile distanza. Ho cercato e trovato l’ulivo piantato da Atena sotto la Loggetta delle Cariatidi, presa anch’io da questo rispetto religioso per le divinità che ancora anima i Greci. Purtroppo la storia, la brutta storia, è salita anche al Partenone, reso arsenale dai Turchi a fine Seicento e attaccato per questo dai Veneziani: non c’è da esserne fieri. Ma ha resistito su quelle colonne, imperfette e diseguali per creare insieme la perfezione e procedere con noi, accompagnando i nostri passi, se vi camminiamo a fianco. Avrei voluto farlo, ma alcuni fastidiosi quanto necessari ponteggi mi hanno privato di questa emozione. Ma mi fido della parola di Elena che, chiedendoci continuamente di stare vicini vicini, ci racconta di due amici, uno scrittore ed uno scienziato, che da un monte lontano osservavano l’Acropoli, circondati dal silenzio e forse in pace con se stessi. Lo scienziato più tardi scriverà, senza contraddirlo, che il suo amico scrittore ebbe l’impressione che il Partenone “si muovesse”. Lo guardo, mi sembra fermo e solido, ma ci credo assolutamente a quest’altra bella storia.
Di sera andiamo a cena in un locale tipico alla Pláka. Lì si balla il sirtaki e si canta “O sole mio”, fuori piove a dirotto, ma che importa. La pioggia è provvidenziale in questi giorni di caldo estivo. Siamo in Ottobre.
Nel locale, molto simile alle nostre taverne, i camerieri sono merce rara. Si fanno vedere di tanto in tanto e quando appaiono parlano tra loro con toni accesi, guardano di qua e di là come se dovessero acciuffare un ladro da un momento all’altro secondo un piano prestabilito, fanno acrobazie tra i tavoli pieni zeppi di affamati clienti. Saremmo stati in quattrocento, in un locale in cui i fumatori hanno ancora vita facile. Anche le posate sono acrobatiche: ogni tanto ne vola una e, dopo aver assaggiato la timida e dura fotocopia di quello che abbiamo sinora mangiato nei vari ristoranti, dalle mani dei camerieri vola anche, in direzione delle nostre, qualche ottimo dolce al miele, i kataÏfi. Quei dolci sono una consolazione: sino a quel momento avevamo tanto apprezzato la cucina greca: la chórta (crostata di verdure), la mousakás, l’insalata greca (la choriátiki saláta), souvlákia (spiedini di maiale), involtini di qualunque cosa in foglie di vite (i ntolmádes) e poi la Feta e yogurt e frollini… Niente ouzo. In albergo ci aspettano ancora le valigie: appena disfatte, dobbiamo rifarle. Sono già pesanti di ricordi.
Siamo già lanciati verso il Peloponneso, verso il ritorno: la giornata sarà lunga fino al porto di Patrasso, con sosta a Epidauro e Micene. Soste brevi perché il tempo è tiranno. E via verso il canale di Corinto. “A destra c’è Tebe”, e parte la leggenda di Edipo: ripasso una storia letta, ascoltata e vista in un teatro. Certo, qui è diverso. Dieci minuti, non di più, al teatro di Epidauro, a provare cosa provavano gli spettatori in cima alle gradinate. Qualcuno al centro improvvisa un monologo, qualcun altro prova ad accendere un fiammifero, a strappare un foglio di carta. Che acustica, senza ingegneri laureati! C’è ancora odore di terra bagnata. La pioggia di ieri sera ha fatto danni nei dintorni. Bisogna far attenzione a non scivolare ma dobbiamo correre a Micene, alla Porta dei Leoni, alla tomba di Agamennone, dove le nostre voci acquistano un’altra forma. Anche il pranzo deve essere veloce e veloci gli ultimi acquisti. Marco al nostro tavolo se la prende comoda: “ma dove vanno se io sono ancora qui?” Neanche lui sa cosa ci aspetta poco dopo. Il pullman, che sino ad allora ha ansimato per curve e salite, decide di fermarsi. Si arrende e sbuffa nero di fumo. Non vuole portarci via. “E’ pericoloso stare qui” e subito viene approntato un piano di evacuazione in un campo pieno di sterpaglie, dove ci accampiamo ridendo fino in fondo, ancora una volta, sotto un sole implacabile, al riparo di ombrelli (che ieri son serviti per la pioggia) e ritagli di ombra.
Il nostro pullman è in curva, la strada è stretta come tutte d’altronde, la polizia greca è piuttosto alterata. Succede un incidente tra due moto che s’agganciano per superare il nostro mezzo: vola un casco, qualche imprecazione ma nulla di grave.
La nave sta ormai per partire e noi siamo ancora lì a 15 chilometri da Corinto: filmiamo tutto per continuare a ridere nel tempo. Con due pullman greci raggiungeremo Patrasso con un’ora e mezzo di ritardo. Provo un sentimento di nostalgia per qualcosa di bello che sta per terminare misto a un grande desiderio di casa. Continuo ad osservare il paesaggio e ad ammirare l’infinità di piante di ulivo: le colline scavate (da cosa? frane? corsi d’acqua spariti? Elena, intenta a portarci in salvo, non parla più) accolgono nel loro grembo sventrato giovani uliveti sorvegliati da cipressi alti e dritti come spade. Sembrano anfiteatri che si spalleggiano, per centinaia e centinaia di metri, quasi identici uno all’altro. Della Grecia mi rimarrà anche questa ricchezza del paesaggio.
La “Minoan Lines” è già partita, ma la lussuosa Superfast V può aspettarci. Stare lì per circa venti ore sarà come fare una crociera nell’Adriatico, con pranzo vista mare. Tutto sommato nel cambio ci abbiamo guadagnato.
Saliamo a bordo: è ancora territorio greco, in acque greche, ma lì mi sento già in Italia.