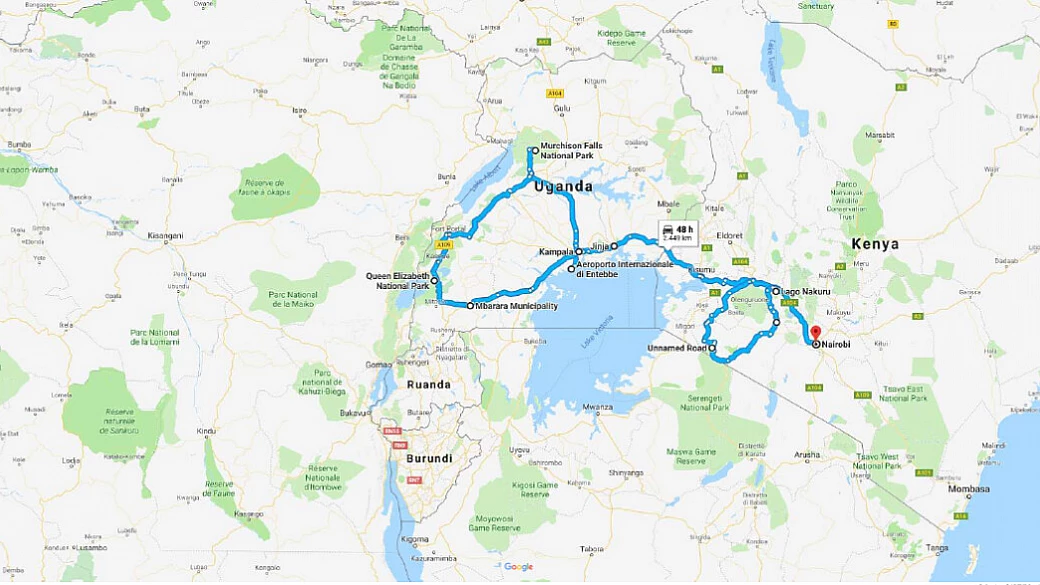Mali, l’Africa più vera

Sankum, la nostra guida Songhai, ci ricorda che è ora di andare, ci aspetta un giro per il mercato. Ma Bamako, il cui nome significa “Il fiume del coccodrillo”, è tutta un mercato, ogni strada è piena di gente che vende e compra di tutto, a volte si ritrova l’ordine dei mercati arabi: tutti i prodotti alimentari da una parte, i dolci dall’altra, le scarpe di qua ed i vestiti di là, la benzina (in bottiglia) su un banchetto ed i ricambi di motori sparsi per terra. Ma spesso c’è un po’ di confusione e fra il traffico caotico di auto, pullman, motorini e biciclette trovi di tutto e tutto assieme; passiamo davanti al Gran Marché ricostruito in parte dopo l’incendio del 1993, e scendiamo lungo una larga via dedicata al riciclaggio. Nulla si butta, da auto e camion in demolizione si ricavano, carriole, contenitori, bracieri, recipienti per il mangime degli animali ed un sacco di altre cose. Sul lato opposto troviamo montagne di materassi, e subito dopo il settore delle macellerie, tutte “moderne”, nel senso che un vetro divide le mosche interne da quelle esterne. Poi iniziano le bancarelle delle verdure, colori a non finire; e non ci fanno mancare il pesce secco, misto anche a serpentelli secchi, e proprio di fianco un banchetto di casalinghi (mestoli, grattugie per il formaggio e … perette per il clistere). Una “grand mama” prepara la crema di arachidi ed uno stuolo di ragazzini ci seguono incuriositi dalle nostre attrezzature da perfetto turista che “spreca fotografie” sul pesce secco. Il primo bagno di colori, odori e varia umanità che sono i mercati africani sta per finire: dobbiamo andare a pranzo.
Al ristorante il personale di sicurezza tiene a bada i venditori; che favola essere in pantaloncini e maglietta il 27 dicembre e mangiare all’aperto con le ventole che ti rinfrescano un po’ dai 30 gradi dell’aria. Per fortuna il caldo è secco e quasi non si sente. Faccio il mio primo incontro con “le capitain”, uno dei pesci più comuni nel Niger: mi servono un piatto proprio buono con pesce fritto guarnito di una certa salsina e con patate fritte di contorno. Se i pranzi saranno così, le scorte alimentari portate dall’Italia non serviranno: troppo presto per dirlo.
Ripartiamo, anzi partiamo da Bamako alla volta di Segou. La città è a circa 220 km a nord-est della capitale, sulla riva destra del Niger.
La strada prosegue diritta nella campagna sconfinata; in Africa sono le distanze a colpirti, le strade che continuano dritte per chilometri e non ne vedi la fine. Ogni tanto un piccolo villaggio, case basse, baracche e capanne, anche se enormi cartelli annunciano, cabine telefoniche, negozi di alimentari e posti di ristoro. Ma quello che colpisce è sempre la gente e soprattutto sono i bambini che, in particolare nelle zone rurali, hanno nell’arrivo dei turisti una vera e propria festa. Quante cose portano questa gente strana: biro, matite e caramelle, ma anche fazzolettini di carta e salviettine profumate che si buttano dopo averli usati! E’ troppo per chi è abituato a non sprecare niente ed a riutilizzare qualsiasi cosa.
Ci fermiamo in un villaggio bambara dove le donne lavorano le noci dell’albero del Karitè, detto anche albero del burro, perché dai suoi frutti si ricava un grasso vegetale, simile al burro di cacao, usato sia come grasso alimentare che come prodotto di bellezza.
Il villaggio sorge lungo la strada, attorno alla moschea di banko, un impasto di fango e paglia usato proprio per le costruzioni; anche le povere case circostanti sono di fango ed i primi granai, simili ai più noti granai dei Dogon. Ne troviamo tre costruiti all’interno di un recinto appartenente alla stessa famiglia, hanno forma circolare, sono sollevati dal suolo e hanno il tetto conico; una piccola porta di legno è l’unica apertura. Qui le porte sono di assi di legno liscio, ma i Dogon hanno l’usanza di scolpirle e renderle uniche.
Dove vedi una nuvola di bambini al centro ci sono Fabrizio e Simona; solo loro hanno il potere di conquistare la loro attenzione, certo con i regali che portano in abbondanza, ma anche con tanti giochi che li divertono tanto; io non ci riesco mi ci vuole qualche giorno per abituarmi alla miseria di questa gente, ai bambini scalzi e malvestiti, alla loro semplice felicità di fronte a noi “ricchi bianchi curiosi”. Qualche bimbo ha il ventre gonfio, ci dicono non per malnutrizione ma per le varie infezioni intestinali, altri hanno infezioni agli occhi e al naso; qualcuno più sfortunato porta i segni della poliomielite: in Mali c’è un medico ogni trentamila persone e sicuramente la situazione diventa più difficile nelle zone lontane dalla città.
Partiamo dal villaggio e maciniamo ancora un po’ di strada, siamo un po’ in ritardo; in Africa è meglio non muoversi col buio, non tutti conoscono alla perfezione le regole stradali e quindi diventa pericoloso circolare dopo il tramonto. Facciamo solo una breve sosta per bere qualcosa in un altro villaggio e rincontriamo i variopinti pulmini del trasposto che avevamo già visto in Senegal. Incredibilmente pieni di gente sono anche stracarichi di merce e di animali: dei giovani stanno scaricando alcuni agnelli legati sul portapacchi fra cumuli di mercanzia, sembrano morti. No, sono solo svenuti dal caldo ed una volta a terra si riprendono, ma è meglio preoccuparsi delle persone… Arriviamo all’hotel de l’Indipendance dopo il tramonto; l’albergo nella sua semplicità è accogliente. Lo gestisce una famiglia libanese e non è certo il grandhotel, ma lo consiglio a chi passa da Segou: è essenziale, ben curato e pulito; anche la cena che consumiamo in giardino è ben cucinata. Poi la stanchezza vince sulla curiosità e sulla voglia di conoscere meglio i compagni di viaggio: ci siamo meritati una bella dormita.
28/12/2003 Segou-San-Mopti Si parte all’alba, si non proprio ma comunque presto; facciamo colazione in giardino e poi controlliamo che vengano caricati i bagagli; Salif, il nostro autista, Sankum e Baya, un giovane studente peul che parla italiano e sta imparando il mestiere di guida, sono indaffarati. Hanno dormito in una sala per le conferenze nel cortile posteriore. Sbircio fuori dal recinto dell’hotel dove riprende a poco a poco il movimento e la vivacità di tutti i giorni ma visiteremo la città al ritorno ed ora dobbiamo riprendere la strada per Mopti. La prima tappa sono un gruppo di grossi baobab: una mandria pascola nelle vicinanze e, non si sa da dove, ma sbucano presto alcuni bambini a cercare il cadeau. Il baobab è l’albero simbolo dell’Africa, anche se mi sembra di aver letto che è originario del Madagascar; è un albero che raggiunge grandi dimensioni e può vivere anche 400 anni. La leggenda dice che l’albero in tempi antichi offese un dio che, come punizione, lo sradicò e lo ripiantò nel terreno a testa in giù; così si spiegano i suoi rami deformi simili a radici. Proseguiamo il viaggio e sostiamo ancora in un villaggio bambara; l’etnia costituisce il 30 % circa della popolazione del Mali e vive sopratutto nelle regioni di Bamako e Segou. La sua omogeneità è dovuta principalmente alla lingua, facilmente assimilabile, che è divenuta nel corso degli anni una delle più diffuse in Africa Occidentale. Riprendiamo la marcia e ben presto arriviamo al ponte sul fiume Bani, il più importante affluente del Niger, in cui confluisce a Mopti. Si forma 160 km ad est di Bamako dalla confluenza fra i fiumi Baoulé e Bagoé, provenienti dall’alta Costa d’Avorio. Il fiume lungo quasi 1100 km, è ricco di acque e forma col Niger un ampio delta interno dove, grazie all’irrigazione ed alle piene stagionali, ci sono ampie coltivazioni di miglio, riso, sorgo, mais destinati al fabbisogno alimentare della popolazione. Sul fiume abbiamo visto i pescatori Bozo all’opera e le loro donne, provenienti del vicino villaggio, intente a fare il bucato. La giornata è proprio bella, la luce giusta per le fotografie. Ne sto scattando davvero tante ma saranno, assieme al ricordo, l’unica traccia del mio passaggio da qui e la testimonianza del viaggio. Al villaggio alcune signore stanno attendendo con grandi ceste colme di pesce appena pescato; non vogliono essere fotografate; poi arriva un pulmino e tutto viene caricato fra le urla e le imprecazioni delle signore che vedono cadere un po’ di pesce dalle ceste mentre vengono issate sul portapacchi. Il pulmino parte con una fumata nera e la mia attenzione viene attirata dal clamore dei bambini che fanno a botte per le biro, ma una gran mama sequestra tutti i regali, li ridistribuisce e tutto si calma. Partiamo alla volta di San dove sosteremo per il pranzo; la guida scrive che il ristorante Teriya, dove siamo diretti, offre la migliore cucina della città. Speriamo. Ci fermiamo per ordinare pollo arrosto e patatine fritte e, mentre i cuochi lavorano andiamo a vistare la moschea di banko. Sono in corso lavori di restauro: tutte le costruzioni di fango dopo la stagione delle piogge devono essere riparate; l’impasto di fango e paglia è tenuto assieme da travi di legno che sporgono dal muro, un po’ per ornamento ma anche come appoggio delle impalcature durante i restauri. La moschea è grande con guglie e piccoli minareti, l’ingresso è vietato ai non mussulmani così possiamo vederla solo dall’esterno. Dopo la moschea visitiamo un laboratorio artigianale di tessuti bogolan, o stoffe di fango. La stoffa è tessuta in strisce di cotone poi cucite assieme e tinte di giallo usando sostanze vegetali. Sulla stoffa vengono poi disegnati dei motivi con diversi tipi di fango colorato, dal rosso all’arancio, fino al grigio e al nero. I bogolan sono poi asciugati al sole e ripuliti dal fango che lascia però i suoi brillanti colori: i tessuti creati con questa tecnica sono davvero sorprendenti. Qualcuno compra, ma io, per non caricarmi fin dai primi giorni, mi trattengo; e poi me ne pento; non ne trovo più di così belli. Pazienza! Al ritorno il ristorante Teriya è strapieno di turisti; anche se abbiamo ordinato e ci hanno riservato un tavolo, aspettiamo un bel po’ prima di mangiare o meglio di piluccare qualcosa: il povero pollo doveva essere davvero magro e le patate hanno un colore tutt’altro che invitante, ma non è il caso di lamentarsi. Saremo più leggeri per i viaggio del pomeriggio: per arrivare a Mopti ci mancano 200 km e non vogliamo fare l’errore del giorno precedente, dobbiamo arrivare prima del tramonto. La strada si snoda nella pianura infinita la brousse, cioè la savana di arbusti, attraversa piccoli villaggi sonnacchiosi, qua e là case, capanne e qualche baobab. Incontriamo grossi camion e pullman di linea, qualcuno in bicicletta e qualcun altro in motorino. A circa metà strada ci fermiamo nel villaggio di Ganga. Gli abitanti sono di etnia Bobo, in prevalenza agricoltori. La loro attività prevalente è rivelata dal gran numero di granai; a Ganga i granai sono a pianta quadrata, sempre sollevati da terra per proteggerli da topi e termiti; il tetto di paglia a forma di cono. La particolarità sta nei disegni ricavati a rilievo sul fango. I granai hanno diverse dimensioni: più il granaio è grande, più la famiglia è ricca. Siamo circondati come al solito da una nuvola di bambini che ci accompagnano nel villaggio. Troviamo tre donne che macinano il miglio ed un granaio è aperto da un giovane uomo che ne estrae un po’ di pannocchie, poi rimette a posto la porta e la sigilla con del fango fresco. Simona distribuisce le candele e riscuote un grande successo, mentre noi continuiamo la visita agli orti cintati che sorgono verdissimi di fianco al villaggio. La sosta successiva è Somadogou; è giorno di mercato ed il piccolo villaggio, che sorge sui due lati della strada, brulica di gente e venditori; i colori e gli odori sono i soliti, anche se le bancarelle che cuociono gli spiedini attirano la nostra attenzione. Lasciamo la strada e ci infiliamo nel cuore del mercato: non ci sono i settori, è un susseguirsi di friggitorie, bancarelle di verdura, di scarpe, di vestiti, di pentole e stoviglie. Qualcuno non vuole essere fotografato altri si mettono addirittura in posa. Poi sulla strada passano due camion e devono faticare non poco per far spostare la folla. Tutti comprano e vendono; i ragazzini offrono i loro ghiaccioli: piccoli sacchetti di plastica con un liquido ghiacciato che poi succhiano da un piccolo foro. Decliniamo l’offerta di assaggiarne uno e risaliamo sul pulmino. Nessuna altra sosta fino a Mopti dove ci aspettano le comode camere dell’hotel Kanaga che si trova proprio sul viale dell’Indipendenza sulla riva destra del Niger, nella città nuova. Le informazioni della guida circa la cucina “non sempre all’altezza”, diventano profezia, quando finalmente riusciamo a sederci a tavola il bel bouffet è desolatamente vuoto; è destino di oggi stare leggeri. Ma il gruppo ormai è affiatato e anche questa sventura è motivo di scherzi e risate. Dopo cena facciamo una piccola passeggiata in riva al Niger, la luna con la “gobba” rivolta verso il basso, illumina l’acqua del fiume, le pinasses sono ancorate alla riva e qualcuno ancora traffica fra le reti o sistema il carico con il sottofondo musicale di Salif Keità: Moffou è la colonna sonora di questo viaggio; domani dobbiamo procurarci il cd. 29/12/2003 Djenné La strada per Djenné non è lunga: per un po’ ripercorriamo la carrozzabile fatta ieri in direzione opposta, poi deviamo verso ovest e il corso del Bani. La regione che attraversiamo è detta la Macina, un ampio delta, formato dai fiumi Bani e Niger. Il terreno è ricco di acqua ed in alcuni casi paludoso, quindi viene coltivato il riso; niente a che vedere con le nostre risaie, queste sono stabili e probabilmente il riso viene coltivato a ciclo continuo. Djenné si trova su un’isola e per raggiungerla bisogna attraversare il corso del Bani su delle chiatte; ho letto tutto nel libro “Le radici nella sabbia” di Marco Aime. Ma quando è venuto l’autore? Ieri? La scena è la stessa: la fila dei fuoristrada e dei minibus, i bambini che vendono piccoli modellini di macchinine fatti con la latta; le due chiatte arrugginite che caricano e scaricano in continuazione centinaia di persone e mezzi arrivati per il mercato del lunedì. Per non perdere tempo il nostro bus non guaderà il fiume: dall’altra parte ci aspettano alcuni fuoristrada che ci porteranno in città. Sull’isola troviamo la stessa venditrice di pesce fritto che ha incontrato Aime; l’ho detto che è venuto ieri! A Djenné poco è cambiato nel corso dei secoli. La città fu fondata nel IX secolo ed è così una delle città più antiche dell’Africa occidentale. Conobbe il suo periodo più fiorente nei secoli XIV e XV, durante i quali al pari di Timbuctu trasse profitto dai commerci transahariani. La sua prosperità si protrasse per molti secoli: quando l’esploratore francese René Caillé visitò la città all’inizio del XIX secolo, riferì che gli abitanti godevano di un buon tenore di vita, si nutrivano in abbondanza, quasi tutti sapevano leggere, nessuno girava scalzo e tutti sembravano svolgere un ruolo utile alla comunità. Le attrattive principali della mitica “città delle undici porte” sono la grande moschea ed il Grand Marchè del Lunedì che si svolge nello spiazzo e nelle vie circostanti la moschea. Entriamo per una delle porte rigorosamente di fango e troviamo uno spettacolo che difficilmente dimenticheremo. La piazza fra le Poste ed il Tribunale brulica di venditori e clienti, dalla strada alla nostra sinistra arrivano in continuazione vecchi carri trainati da buoi, stracolmi di merce. Sicuramente qualcuno ha fatto decine di chilometri per venire a vendere la propria merce al mercato e sotto le tettoie di legno c’è proprio di tutto: verdure, vasi, cesti e contenitori di plastica (va di moda il bicolore giallo e blu), pesce secco, pesce fritto, pesce fresco ed anche pesce in uno stato indefinibile; animali di ogni tipo e taglia, riso, miglio … Noi cerchiamo di farci strada tra la folla in direzione della moschea: ed eccola la più grande costruzione al mondo interamente di banko. E’ davvero incredibile che un edificio tanto grande sia costruito con fango e paglia, e si capisce perché ogni anno, alla fine della stagione delle piogge, centinaia di volontari (la guida Lonely planet dice fino a 4000) lavorano per la sua manutenzione. Sempre dalla guida leggiamo che la costruzione attuale risale al 1907 e fu riedificata sulla precedente moschea voluta nel 1280 dal 26° re di Djenné, chiamato Koi Komboro convertitosi alla nuova religione arrivata dalle regioni saheliane “a dorso di cammello” assieme ai mercanti sarakollè che commerciavano con l’oriente. Lasciamo la folla del mercato per inoltrarci nelle viuzze che circondano la moschea; qui, oltre il muretto, che delimita l’area “vietata ai non mussulmani”, conosciamo il guardiano della moschea, che ci sorride e saluta cordialmente. Per le strade non interessate dal mercato, troviamo solo i bambini, loro sono molto più interessati a noi che alle tante cose che non possono comprare; così scattiamo qualche foto con loro ed intanto raggiungiamo nuovamente la piazza del mercato dal lato meridionale. Ci ributtiamo nella folla variopinta e rumorosa del mercato e cerchiamo di raggiungere il lato opposto della piazza: dalle terrazze delle case la vista sulla moschea è splendida: le tre torri volte ad oriente svettano illuminate dal sole di mezzogiorno in un gioco di luci ed ombre creato dalle decine di pinnacoli e dalle travi sporgenti dal muro; sotto il mercato, un formicaio di gente intenta a vendere e comprare di tutto. Ma anche noi vogliamo partecipare al “bagno di folla” ed eccoci di nuovo fra le bancarelle a curiosare fra le cose per noi più strane. Ci sono anche i giornali a fumetti: più della metà della popolazione del Mali non sa leggere e scrivere così le notizie ed i fatti sono raccontate con immagini e brevissime didascalie che qualcuno legge agli altri. Sono stato colpito da questo angolo del mercato: decine di persone, soprattutto i giovani, erano intente a vedere le vicende della guerra in Iraq, la cattura di Saddam, ma anche i risultati di calcio e, con ampio spazio, la boxe, la lotta ed i campionati di culturismo. La strada mi ha poi riportato nella piazza delle poste e così ne approfitto per comprare i francobolli per un mio amico collezionista. L’ufficio postale è costituito da un bancone e un addetto che mi passa i fogli interi da cui mi strappo i francobolli; un francese mi consiglia sulla scelta pensando che io lo comprenda, poi capisco che sta aspettando che io paghi i francobolli per avere il suo resto dal postino. Ritrovo gli altri davanti al ristorante Chez Baba: lo ricordo perché ho letto che ospita le tende anche sul tetto: una cosa che lì per lì mi ha stupito, ma poi ho scoperto che in Mali è una cosa abituale. Sankum e la guida locale ci accompagnano ora fra le vie della città: le case hanno tutte almeno due piani, a pianterreno c’erano i magazzini, al primo piano stavano i servi mentre il padrone occupava il secondo piano. Alcune conservano decorazioni ed infissi in stile moresco ma una caratteristica le accomuna, sono tutte di fango. Alcuni operai stanno riparando la linea elettrica e staccano i cavi proprio sopra alle nostre teste; ci sbrighiamo per evitarli e raggiungiamo la casa di un artigiano di tappeti dove ci riposiamo un po’ nella bottega polverosa in attesa di andare a pranzo. L’avventura del guado del fiume si ripete al ritorno a metà pomeriggio. Questa volta assistiamo anche al carico dei mezzi con alcuni episodi davvero singolari: fuoristrada incastrati e pulmini stracarichi impantanati nel fango del fiume. Infine scopriamo che a guidare la chiatta è un bambino. Sostiamo al villaggio di Syn, abitato da popolazioni Bozo, Bobo e Peul. Syn ha una bella moschea in stile sudanese a cui fanno corona le povere case di banko e una serie di granai quadrati. Qui i bimbi che ci vengono incontro sono davvero simpatici: il villaggio non è una meta abituale dei turisti e per loro è tutto una novità. Anche noi vorremmo trattenerci di più ma ci aspetta il tramonto a Mopti e dobbiamo affrettarci. La città sorge proprio alla confluenza fra i fiumi Bani e Niger, circondata da acquitrini e campi di riso, per questo è soprannominata, e lo dico solo per dovere di cronaca, la “Venezia del Mali”, in realtà di Venezia ha ben poco. La città è abitata da una ricca varietà di etnie diverse: secondo la tradizione fu fondata nel luogo dove i pescatori Bozo ed i pastori Peul si incontravano per commerciare; ora per le sue strade polverose si trovano anche Bambara, Dogon, Tuaregh e Toucouleurs (ed il nome è tutto un programma). Arriviamo proprio al crepuscolo. Scendiamo davanti alla Misire Mosquee che di eleva sulla parte vecchia della città; costruita nel 1935, sembra non essere di fango, come le altre moschee dello stesso stile, solo la parte inferiore viene periodicamente ricoperta di fango. Poi percorriamo il ponte che attraversa la palude e passiamo alla città nuova e al porto dove le pinasses e le piroghe stanno facendo ritorno dopo la pesca. Si scarica il pesce appena pescato, la legna trovata nel fiume ed anche il sale arrivato da Timbuctu; tutto attorno direttamente sulla spiaggia è una mescolanza disordinata di bancarelle che vendono di tutto: legna, terracotte, calebasse, vestiti, stuoie, mobili, e più in là sulla strada, anche la verdura e il cibo. Ma lo spettacolo davvero unico è il tramonto sul fiume: ce lo godiamo tutto durante il ritorno a piedi all’hotel: i colori si scaldano, le ombre si allungano e poi il sole “si tuffa” nelle acque fangose e a poco a poco scompare.
30/12/2003 Paesi Dogon Inizia l’avventura che aspettavo con più impazienza: la visita ai paesi Dogon. Partiamo da Mopti in direzione di Bandiagara, una piccola cittadina polverosa a circa 80 km ad est della città capoluogo. La città non ha nulla di particolare e l’attraversiamo velocemente senza neppure fermarci; alla periferia dell’abitato, appena dopo il centro di medicina tradizionale, che tutti conoscono per la sua architettura particolare a igloo, inizia la strada sterrata che ci porterà a Sangha, vicino alla sommità della Falesia, distante 45 km. Il bus inizia a ballare ed iniziano anche le prime crisi di mal d’auto. La prima sosta ci introduce già al mondo dei Dogon. La roccia dell’altopiano si tinge di verde e scopriamo che il duro lavoro di questa gente ha utilizzato ogni lembo di terra ricavandone piccolissime terrazze quadrate dove si coltivano miglio e cipolle. Il popolo Dogon è tradizionalmente legato all’agricoltura e tutti, sia uomini che donne, si danno da fare per ricavare nuovi appezzamenti di terra, costruendo dighe sui corsi d’acqua e trasportando la terra dalle zone pianeggianti. Il paesaggio che scopriamo è verdissimo: una piccola valle racchiude un corso d’acqua, ingrossato da uno sbarramento artificiale; le piccole terrazze degradano sulle due sponde e decine di persone sono intente ad irrigarle attingendo l’acqua con delle calabasse trasportate poi in testa. Le zone coltivate sono delimitate da cumuli di canne secche raccolte a formare delle specie di siepi, forse delle barriere per la polvere e la sabbia. Siamo appena scesi e già accorrono i bambini; sbucano da ogni lato della strada anche se nelle vicinanze non vediamo villaggi. Nel giro di pochi minuti siamo già circondati. Eccoli il futuro del misterioso popolo dei Dogon, fatto conoscere al mondo poco più di cinquant’anni fa dall’etnologo francese Marcelle Griaule. Lo studioso li studiò per circa quindici anni, e riuscì a trascrivere la loro singolare cosmogonia, che tutto spiega e tutto contiene della vita e del mondo, grazie alla fiducia di un vecchio hogon (sacerdote) cieco. Il suo libro, “Il dio d’acqua, incontri con Ogotemmeli”, è diventato famosissimo ed il mondo ha così potuto conoscere questo popolo che conta oggi circa 400.000 persone e che vive nei numerosi villaggi arroccati all’enorme Falesia di Bandiagara, una aspra e spettacolare formazione rocciosa. La falesia si sviluppa per circa 150 km con un’altezza di circa 300 m e si presenta come un colossale gradino fra l’altopiano e la pianura del Seno. La guida racconta che i primi abitanti della zona furono i Tellem, che la tradizione Dogon vuole di pelle rossa e di bassa statura. Dapprima i Tellem si sistemarono nelle grotte naturali presenti sulla superficie della Falesia per sfuggire alle scorrerie delle tribù della pianura. Poi svilupparono l’uso del banko e costruirono case e granai a forma di cono tronco, che vediamo ancora oggi incastonati nelle grotte della scarpata. Queste costruzioni, sono raggiungibili solo utilizzando delle corde, calate dalla sommità della scarpata e sono ancora oggi usate come tombe dai Dogon. I Tellem si estinsero per assorbimento, mescolandosi lentamente con un popolo di invasori di razza Mandingo, forse i Mossi del Burkina Faso, circa 600 anni fa. Secondo una teoria fu dall’incrocio delle due etnie che nacquero i Dogon, che ereditarono le antiche tecniche di costruzione ed iniziarono ad edificare i loro villaggi sempre più in basso, fino nella pianura stessa. Intanto abbiamo ripreso la marcia, sballottati a destra e sinistra dalle asperità della strada; dopo qualche chilometro serve un’altra sosta ed abbiamo un’altra occasione per ammirare le verdi terrazze nelle valli dei torrenti. Non conosco i nomi delle località e dei piccoli villaggi che abbiamo visto lungo la strada, mi piace comunque ricordarne uno, letto sulla cartina, ma impronunciabile: “Luogourougoumgou” . Che ne dite?. E’ qui, nella campagna anonima, dei villaggi dell’altopiano che un bambino mi ha regalato il disegno della maschera che tengo come ricordo più prezioso di questo viaggio; il bimbo è sparito subito con la monetina che qualcuno del gruppo gli ha dato in cambio, così ho saputo il nome del piccolo artista, forse Amodonbou, solo da un altro ragazzino.
La strada si snoda sull’altopiano roccioso ed arriva a Sangha e poi al villaggio di Bongo, dove abbiamo sostato sulla spianata di fronte all’enorme galleria naturale, tra le grida e le gare dei ragazzi che si offrono come portatori. Iniziamo qui la nostra camminata, da ora in poi visiteremo i villaggi a piedi, come consigliano tutti gli scrittori sui Dogon, da Aime a Franchini. La sorpresa è ad ogni angolo, ma bisogna stare attenti perché la complessa cosmologia ha impregnato a tal punto la vita di questo popolo che ogni oggetto, ogni pietra, ogni piccolo gesto quotidiano, per noi insignificante, può essere un simbolo sacro (un omolo), la cui violazione può provocare una grave offesa. Ne fa le spese Simona che fotografa alcune donne intente a macinare il miglio, le ho fotografate anch’io, ma la sua macchina fa rumore ed è subito rissa, fra noi, sbigottiti per la brusca reazione, le nostre guide ed i portatori da una parte e le signore arrabbiatissime dall’altra. La “rissa” si calma e possiamo goderci la vista spettacolare sulla piana del Seno; sotto ai piedi della falesia i villaggi di Némi, Banani-ama e Banani kokoro. Percorriamo le strade di Bongo ed abbiamo la sorpresa di sentire i bambini che cantano un’allegra tiritera, riesco anche a registrare alcuni secondi della canzone, un ricordo davvero unico. Ad un certo punto il sentiero piega verso lo strapiombo e prosegue in discesa in una spaccatura della roccia. Il sole di mezzogiorno è caldo ma assolutamente sopportabile: incominciamo a scorgere le prime cavità della rocce della falesia con le costruzioni di banko dei Tellem; una cascata precipita dalla scarpata con un effetto unico: chissà nella stagione delle piogge. I grigi baobab e le verdi chiome delle acacie decorano la parete rocciosa, mentre i villaggi con i granai dal tetto di paglia di forma conica e le caratteristiche case di fango sembrano dei presepi aggrappati alla roccia. Sostiamo a riposare sotto un baobab e vediamo un omolo, un altare sacro, con tanto di galletto sacrificato per proteggere il villaggio contro particolari pericoli: è un semplice cumulo di sassi alto 50 cm, ma toccarlo sarebbe sacrilegio. Continuiamo verso la tai, cioè la piazza, dove vediamo i primi venditori di porte scolpite con i motivi elaborati, simboli della religione dogon. Più in alto, in posizione dominante, sorge il Togu-na, letteralmente il “riparo madre”, ma più comunemente tradotto come “la casa della parola”. E’ un riparo dal tetto costituito da vari strati di fascine di paglia sorretto da nove pilastri, di cui gli otto esterni sono decorati con i simboli degli altrettanti antenati. Il togu-na è il luogo dove l’Hogon e gli anziani del villaggio si ritrovano per prendere le decisioni importanti o più semplicemente per stare assieme a fumare, scherzare o riposare. La tettoia è molto bassa: nella casa della parola si può stare solo seduti e calmi, chi si innervosisce, finisce per sbattere la testa contro il soffitto. Saliamo al togu-na e vi troviamo l’hogon ed alcuni anziani: è un momento emozionante. Anche se la frequentazione turistica ha molto semplificato il cerimoniale, il contatto con il sacerdote del villaggio va sempre fatto con molto rispetto attraverso un intermediario (il kadana) a cui bisogna consegnare i doni o l’offerta per la birra di miglio. Sankum parla direttamente con l’hogon che accetta anche di essere fotografato; poi parliamo della complessa e raffinata religione. I Dogon dicono di discendere dal dio Amma proveniente dalla stela Po-tolo, che è anche il nome del seme del fonio, un cereale dai grani piccolissimi, simbolo della forza vitale. La stella, bianca, piccola e molto densa, come il fonio, è stata identificata come Sirio B, una nana bianca, poco più grande della Terra, ma con una massa pari a quella del Sole; gli astronomi occidentali l’anno scoperta solo nel 1862 (e fotografata solo nel 1970) ed hanno calcolato che descrive un’orbita attorno a Sirio di circa cinquant’anni. I Dogon conoscono da sempre queste informazioni e le usano per determinare il periodo della festa del Sigi, che si svolge appunto ogni, 50 o 60 anni circa per celebrare la comparsa della stella e della sua forza fecondatrice in un punto preciso dell’orizzonte (il prossimo appuntamento sarebbe per il 2020). Amma creò l’universo con le stelle e le costellazioni e poi creò Tenga, cioè la Terra, a forma di donna, con cui si accoppiò generando i Nommo, due esseri mezzo uomo e mezzo serpente, identificati come la forza vitale dell’acqua, e li inviò sulla terra a portare la parola. Come prima cosa i Nommo circoncisero l’uomo e la donna, perché creati da Amma con la doppia essenza maschile e femminile (il prepuzio, detto nay, la lucertola, sarebbe la parte femminile dell’uomo, il clitoride, cioè lo scorpione, la parte maschile della donna) ed essi generarono otto figli, quattro maschi e quattro femmine. Loro popolarono la terra ed impartirono, attraverso la Parola, gli insegnamenti fondamentali, come la tessitura, la metallurgia e l’ agricoltura.
Ringraziamo l’hogon di Banani ma ora noi abbiamo fame e in un attimo scendiamo a Banani-kokoro dove sostiamo per il pranzo. Siamo sistemati su di una terrazza, all’ombra delle stuoie: stiamo davvero bene. Il menù è essenziale: riso, cuscus e pollo. Poi ci concediamo un po’ di tempo per l’acquisto della porta. Non posso astenermi dall’avere la mia porta dogon: certo non pretendo una porta antica ma non il solito souvenir. Così io, Fabrizio, Carlo, Simona e Manuela, ci avventuriamo nei numerosi negozietti del villaggio, che come dice la Lonely Planet, “brulica di venditori”. Anche il ragazzino che mi ha accompagnato nella discesa dalla falesia, si è già attivato per “aiutarmi” nell’acquisto, ma preferisco scegliere. Dopo qualche negozio siamo catturati da un venditore che ci porta nel suo laboratorio, in mezzo alle viuzze del villaggio. Entriamo addirittura nella casa della sua famiglia: alcuni locali si aprono su due cortili; nel primo donne e bambini stanno mangiando da una calabasse, nel secondo vi sono due granai e vari locali. E’ qui il negozio-laboratorio di Siguenne. Gli oggetti sono più curati che altrove e allora scelgo la mia porta: anzi due, una piccola per l’ufficio con scolpito l’hogon e la sua donna e il serpente-nommo, una più grande per casa raffigurante le quattro coppie degli antenati. Anche Fabrizio acquista la sua porta e Carlo la serratura, abbiamo ampiamente contribuito al bilancio della famiglia. Le porte vengono confezionate in un sacco per le galline con tanto di piume originali e portate sul fuoristrada di servizio. Nel frattempo sul tai del villaggio inizia un ballo tradizionale, certo è ad uso e consumo di noi turisti, ma l’atmosfera è unica con il suono dei tamburi, i canti tradizionali, gli uomini e le donne che danzano sotto i baobab e la falesia sullo sfondo. Anche se costruito è un momento magico: forse ha ragione Marco Aime, sono un turista che vede solo “il mondo fatto di simboli cosmici, di misteriose astronomie, di gente che trascorre il tempo a riordinare l’universo secondo mappe ancestrali armoniche e virtuose”. Ma no, ho visto benissimo la miseria, gli sforzi ed il lavoro di un popolo per recuperare nuove terre da coltivare, la voglia di riscatto ed il conflitto generazionale: il venditore che richiede il doppio del prezzo a noi che, per i nostri sensi di colpa, siamo disposti a pagare molto di più del valore; il ragazzino che mi ha accompagnato e che si è fatto comprare le ciabatte facendosi dare la “cresta” dal venditore. Certo i paesi dogon non sono più il mondo incantato descritto da Griaule, ma secondo me è importante che questo popolo riesca a riscattarsi, a migliorare il suo tenore di vita per sopravvivere e tramandare il ricordo della sua cultura e della sua storia. Sono questi i miei pensieri mentre il gruppo riprende la marcia ai piedi della falesia; siamo nella pianura del Seno, a meno di 70 km dal confine con il Burkina Faso: un tempo era una savana verdissima ora è una arida distesa, con baobab, acacie e bassi arbusti, sopra le nostre teste scorrono i villaggi di Bongo, Pegue, Saye e quindi anche Ireli ed in fondo Yane. Arriviamo nel villaggio di Amadingue, due mesi fa c’è stato il presidente Chirac che è stato anche nominato “gran chef hogon”, ce lo vedo sotto al togu-na! Andiamo è ora di montare le tende, ci aspetta una serata unica nell’infinito della savana attorno al falò.
31/12/2003 Paesi Dogon-Mopti Certo non è da tutti svegliarsi all’ultimo giorno dell’anno in una tenda, in mezzo all’Africa; fuori c’è una vista mozzafiato sulla falesia. Il sole sta sorgendo ed è ora di rimettersi in marcia. Oggi, attraverso il villaggio di Ireli, risaliremo la roccia fino a Sangha dove ci aspetta il pulmino. Passiamo ancora da Amadingue ed al suo Togu-na “moderno”, poi iniziamo a salire il sentiero che porta a Ireli. Vediamo in alto, in una spaccatura della falesia, un agglomerato di costruzioni tellem, intorno a noi sorgono invece numerose case, ognuna con il cortile, delimitato da muretti a secco ed il suo granaio. Ad Ireli non troviamo venditori ed anche i bambini sono discreti e schivi; attraversiamo la piazza con l’altare cumulo ed entriamo nel vecchio quartiere attorno al togu-na, che, come di consueto, è in posizione dominante. Su di un muro a lato sono state modellate sul banko le immagini della religione dogon e poi dipinte con colori brillanti: dal bianco al blu, dal rosso al nero. Riconosco la maschera guinna, che rappresenta la casa dell’hogon; il serpente Lebè, che tutte le notti va a leccare l’hogon per infondergli la parola (per non eliminare le tracce della parola l’hogon, può essere toccato solo dalla moglie, e non può lavarsi più di una volta l’anno…) la maschera kanaga, l’antilope, apportatrice di vita, la volpe e l’hogon stesso. Un’altra rappresentazione ricorrente nelle decorazioni Dogon sono le linee a zig-zag, che richiamano il moto perpetuo dell’universo. L’urbanistica dogon vuole che il villaggio sia sempre disposto da nord a sud e che la sua pianta sia simile alla figura di un uomo sdraiato : il togu-na rappresenta la testa, le case con i granai sono il tronco e gli arti, mentre il braccio destro è costituito dallo yapunu guina, la casa dove le donne risiedono durante il periodo mestruale, in quanto impure. La pietra usata per macinare rappresenta l’organo genitale femminile, l’altare a forma fallica, l’organo maschile. Lasciamo l’hogon di Ireli e continuiamo a risalire la falesia; siamo tutti attrezzati con scarponcini e scarpe da trekking e dobbiamo stare attenti ad alcuni passaggi; come faranno le donne dogon a risalire con un bambino legato alla schiena, una calabasse colma d’acqua in testa e, sopra a questa, un sacco pieno? Ce lo siamo chiesti quando una giovane donna ci ha superato così carica: portava solo ciabattine infradito. Il sentiero sale attraverso un profondo canalone eroso dal vento e dall’acqua nel corso dei secoli; le rocce assumono strane forme e le grotte mostrano le tracce delle abitazioni tellem. Piano piano ritorniamo sull’altipiano di Sangha e già vediamo in lontananza le prime case. Sangha è uno dei villaggi più grandi e passiamo vicino alla scuola, alla biblioteca, all’ufficio postale e arriviamo sulla piazza con l’antenna per telecomunicazioni alimentata dai pannelli solari della cabina telefonica pubblica. Vediamo le cipolle, anzi gli scalogni, a seccare al sole, le caratteristiche scale ricavate da un tronco a forcella opportunamente sagomato, e poi ritroviamo la vivacità dei bambini che ci corrono incontro con la consueta allegria. Il tempo, sempre insufficiente, dedicato alla visita dei paesi dogon sta per scadere; da una parte mi dispiace che sia già finito ma dall’altra solo questi due giorni valevano il viaggio intero: un popolo così semplice ma con una cultura complessa e singolare di cui va fiero.
Rientriamo a Mopti nel primo pomeriggio: l’avventura continua sul fiume Niger.
Consumiamo il nostro panino all’hotel e poi ci imbarchiamo su di una pinasse per la navigazione fino a Konna. Viene caricato tutto il necessario per la cena e per la notte; anche questa sera la passeremo sotto le stelle. Le operazioni di carico si protraggono ma poi i primi paesaggi ripagano l’attesa. Il Niger è il terzo fiume africano e nasce dagli altipiani del Fouta Djalon; prima scorre verso nord-est attraverso il Mali, poi piega a sud e, attraverso Niger e Nigeria, si getta nel golfo di Guinea con un ampio delta. In tutto percorre più di 4000 km di cui 1700 in Mali. Nel tratto a nord di Mopti il letto è ampio e le sponde sono basse; passiamo poveri villaggi, i cui abitanti, di etnia bozo e peul, vivono della presenza del fiume. Sul fiume incontriamo piroghe di pescatori spinte a remi, o anche a vela, ed altre pinasses di trasporto stracariche di persone e merci. Filano tutte più veloci di noi, si vede che noi stiamo facendo una crociera. In tre giorni di navigazione da Mopti si raggiunge il porto di Timbuctu e la navigazione è sicuramente il mezzo migliore per raggiungere la mitica porta del deserto. La navigazione fra le due città viene usata soprattutto per il trasporto delle lastre di sale che arrivano con le carovane (azalai) dalle miniere di Taoudenni a 700 km a nord di Timbuctu. Queste miniere sono costituite dai letti di antichi laghi salati prosciugati migliaia di anni fa’ ed il lavoro di estrazione avviene soprattutto nella stagione più fresca da ottobre a marzo; le carovane di cammelli si muovono solo di notte e impiegano 16 giorni per attraversare il deserto. Leggo queste cose dalla guida ed intanto la pinasse scorre sulle acque fino al tramonto. Quando il sole è una palla infuocata sull’orizzonte la barca accosta e, sul fango del fiume, indurito dal sole, rimontiamo le tende; la stanchezza inizia a farsi sentire ed il morale del gruppo è basso. Dopo la cena inizia l’attesa della mezzanotte: da quanto tempo sognavo un capodanno senza luci, suoni e confusione. Sicuramente qui non ci sarà nulla di tutto questo. 01/01/2004 Fiume Niger-Konna-Segou Mai successo che al primo dell’anno mi svegliassi alle 7 ed in una tenda, ma la cosa più sorprendente è che sono riposato ed in ottima forma, e la cosa mi spaventa per gli eventuali futuri sviluppi che questa prova di adattabilità provocherà alla programmazione dei prossimi viaggi. Il resto del gruppo non sta altrettanto bene: ho fatto bene a stare leggero e concedermi per il cenone solo riso bollito e carne in scatola della mia scorta personale (in questo caso è proprio servita). Nonostante qualche malessere non perdiamo tempo e, rifatti gli zaini, risaliamo sulla pinasse e ripartiamo alla volta di Konna. Sankum e gli addetti della barca preparano la colazione davvero abbondante in confronto alla cena: brioches, frutta fresca ed anguria, caffè, te … insomma ogni ben di dio se pensiamo di essere dove siamo. L’aria del mattino è fresca e abbiamo indosso tutto quello che ci siamo portati nello zaino, ben presto però i raggi del sole iniziano a farsi più caldi e la giornata africana si preannuncia bella e calda come sempre. I pescatori sono già all’opera sulle loro piroghe; lanciano le reti, sistemano le nasse, qualcuno ha già un carico di pesce fresco. Passiamo la cittadina di Wandiaka con la sua bella moschea di fango che innalza due torri e numerosi pinnacoli e raggiungiamo un villaggio di pescatori bozo. Sono nomadi e vivono in povere capanne di paglia; attracchiamo e siamo subito circondati da una nuvola di bambini. I colori che vediamo in questo villaggio sono incredibili: gli uomini sono intenti a riparare le reti, le donne puliscono e cucinano il pesce, il ciabattino sta lavorando davanti alla sua capanna assistito da alcuni piccoli apprendisti. Come al solito il nostro arrivo è una festa: Simona non resiste alla tentazione ed ha già in braccio un neonato, Fabrizio è già assediato dalla solita nidiata di bambini, ce n’è persino uno con i riccioli biondi! Dopo aver attraversato l’accampamento allineato alla sponda del fiume, risaliamo sulla pinasse e salutiamo i nostri ospiti; siamo quasi arrivati. La barca devia a sinistra e si infila in un canale laterale che porta al porticciolo di Konna: è giorno di mercato ed il via vai di piroghe e pinasses stracariche è superiore al normale. Arriviamo così in vista della cittadina a metà mattina: il sole è gia caldo ed illumina l’ampio spazio polveroso che separa le case dal canale, decine e decine di imbarcazioni sono già attraccate a riva e dobbiamo avvicinarci ad una pinasse già ormeggiata per scendere dalla nostra. La navigazione è finita, il nostro pulmino è già pronto, ma abbiamo il tempo per fare un rapido giro per il mercato. La gente è tutta attratta da un camion pubblicitario del dado Jumbo; spettacolo di karaoke con le bambine invitate a salire ed esibirsi in canti e balli: a giudicare dalla folla deve essere un avvenimento per la città. Tutto intorno pastori peul e tuareg coperti dai caratteristici taguelmoust variopinti contrattano l’acquisto di bestiame; le vie della cittadina sono affollate di gente di ogni razza che si aggira fra le bancarelle sistemate sotto le precarie tettoie di legno, mentre decine di carri e carretti con cui i venditori sono giunti in città da tutto il circondario sono parcheggiati, con gli asinelli, davanti alla moschea. C’è un’atmosfera strana a Konna; si sente già l’atmosfera del deserto: il lago Debo è ad un giorno di navigazione, la mitica Timbuctu a 230 km a nord.
Risaliamo sul nostro bus e riprendiamo la strada per Mopti; Simona, Manuela, Andrea e Silvia ritornano con noi fino in città, aspetteranno all’albergo l’aereo per Timbuctu del giorno seguente. Noi proseguiremo per Segou e pernotteremo ancora all’hotel de l’Indipendence.
02/01/2003 Il soggiorno all’hotel è sempre confortevole, una doccia, una buona cena ed una bella dormita in un letto ci hanno rimesso di buonumore anche se oggi è l’ultimo giorno del nostro viaggio. Segou e la seconda città del Mali per numero di abitanti; è la sede del vasto progetto di irrigazione chiamato Office du Niger, al centro della principale regione agricola del paese per la produzione del riso. Si ritiene che l’esploratore inglese Mungo Park arrivò sino qui è scoprì così che il fiume scorreva verso est. Durante il dominio francese, la città fu un centro amministrativo molto importante; i suoi ampi viali e i vari edifici in stile coloniale danno l’idea di come doveva essere la città a quell’epoca. Visitiamo il Gran Marchè ed un laboratorio tessile; poi percorriamo il viale che costeggia il Niger e scattiamo ancora qualche foto: le caratteristiche abitazioni bambara in banko rossiccio, i pescatori intenti a gettare le reti, le donne che fanno il bucato, un signore indaffarato a lavare la sua pecora. Sotto agli alberi vi è un grande assortimento di terrecotte bambara prodotte a Farako, un piccolo centro poco distante da Segou.
Lasciamo la città e facciamo un’altra sosta a Segou Koro, centro dell’impero bambara nel 18° secolo; per visitare il villaggio bisogna pagare una tassa al capo-villaggio che ci accoglie sotto ad una tettoia, usata anche come scuola; qui ci racconta i trascorsi storici della sua gente con un’ espressione ed un’enfasi davvero uniche. Arriviamo a Bamako nel primo pomeriggio, una sosta per il pranzo e poi un meritato riposo all’hotel Salam.
Verso sera l’ultima visita al centro della città. Passiamo davanti alla stazione capolinea della ferrovia Dakar-Bamako; il viaggio fra le due città si effettua due volte alla settimana, il viaggio dovrebbe durare 35 ore ma in genere se ne impiegano 40 o più. Il pullman ci lascia a Place de la Republique, dietro alla sede dell’Assemblea Nazionale. Qui c’è il mercato dei feticci. Non fotografiamo niente: la macabra varietà di ossa, pelli, camaleonti secchi, teste di scimmia marcescenti ci lascia sgomenti. Preferiamo la Moison des Artisans, dove spendere gli ultimi franchi. Più che artigiani dovremmo dire venditori, ma se ci si spinge un po’ oltre il perimetro del cortile interno del mercato, effettivamente si trova qualche artigiano che intaglia il legno o lavora il cuoio. Purtroppo l’inquinamento nella Rue de Sobuta, una delle principali direttrici della città, è insopportabile e ci costringe a ritornare nella zona più turistica. Rientriamo in hotel, il programma della serata prevede una cena con musica tipica al ristorante San Toro; purtroppo siamo sistemati in giardino e alle notizie che non servono birra e che hanno finito il pesce decidiamo di tornare in hotel. Così ceniamo nel tranquillo ed elegante ristorante del Salam dove sembra di essere già tornati in occidente. Domani mattina saremo già in Italia.
Le immagini sul sito www.Imieiviaggi.135.It