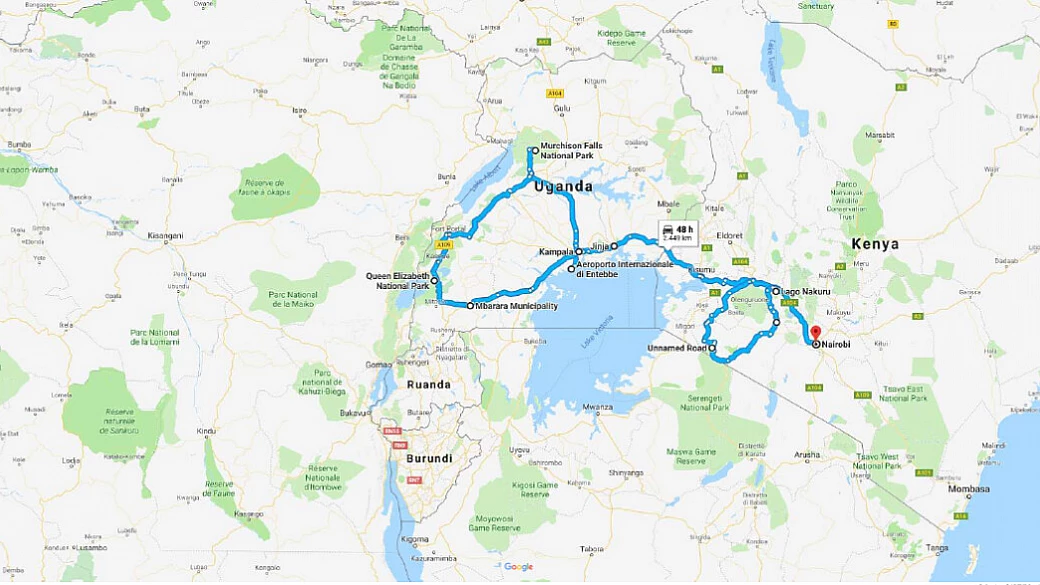La Maledizione delle Mangrovie

Facciamo questo briefing ogni quindici giorni. Illustriamo tutte le nostre belle iniziative con tanto di immagini proiettate sul maxischermo. Lei e Stefano si atteggiano a veterani della colonizzazione e, mentre vengono serviti dei disgustosi soft drinks alla frutta, recitano a memoria sempre la solita pesantissima solfa su tutte le possibili soluzioni di safari fotografici: -Safari di un giorno allo Tsavo Est, o di due giorni allo Tsavo Ovest.
-Safari di tre giorni in ultraleggero sul Masai Mara o di una settimana nel Serengeti o all Amboseli -Safari di un mese bendati e in monopattino o, per i più pigri, Safari a domicilio con sfilata di mammiferi in tutù direttamente nella propria camera.
La filastrocca continua con una snervante dovizia di particolari riguardanti orari, località, prezzi, temperature stimate, nomi e cognomi da nubili delle mamme e delle sorelle degli autisti, nel caso dovessero servire. Ho la nausea. A me invece tocca sempre “vendere” stronzate, come il Malindi City Tour , che dal punto di vista faunistico sembra regina coeli. La grigliata di aragoste + parco marino, che consiste perlopiù in allegre passeggiate su coralli urticanti e una sbornia colossale su una spiaggetta fuori mano, o la visita al rettilario e/o alla falconeria o al villaggio samburu, luoghi di una noia tale che hanno già sostituito la pena di morte in tre stati africani.
Nonostante ciò non ho difficoltà a propinargliele come l’unica valida affascinante ed esotica ragione di un viaggio nel continente africano, eppure quella inutile foresta di mangrovie, che mi sforzo di dipingere come una roba da veri sfigati, esercita su di loro il fascino irresistibile di un documentario di Discovery Channel.
Evidentemente uso la tattica sbagliata. Ma odio quel luogo e non riesco a parlarne in termine entusiastici.
E adesso mi tocca portarceli in ventisette.
Centinaia di dollari buttati in quella melma puzzolente.
Contenti loro!.
Cerco di farmi risultare simpatici tutti gli ignari predestinati a questo viaggio sacrificale che li porterà alla beatificazione attraverso un martirio lento e doloroso. Ma faccio molta fatica.
Adriana, per indorarmi la pillola, ha fatto leva sulla presenza di “chiappe rotanti”: è così che lei chiama Federica, una bella moretta dalla carnagione scurissima e con due liquidi occhi azzurri, ha studiato a New York e mi sembra di aver capito voglia fare la designer.
È venuta con i genitori, separati ma in ottimi rapporti, e ad un amico del padre, sono i più simpatici. I suoi si chiamano per cognome ma si capisce che una volta erano affiatatissimi. Ho già avuto modo di fraternizzare con lei e la mamma.
Le ho accompagnate fino al centro di Malindi, con le bici dell’albergo. Le ho fatto capire subito che mi piace dimostrandomi assolutamente non allenato a pedalare con quel caldo su quel mezzo di locomozione dall’equilibrio approssimativo.
7:00 AM: Partenza Il pagamento è (ovviamente) anticipato. Sono 200 dollari a testa. Cash! Passo davanti la finestra del nostro ufficio per andare sul piazzale e vedo Adriana contare i soldi. Ho un mezzo travaso di bile. – la mia parte me la sputtano tutta al casinò – le bisbiglio acido.
Fa spallucce e gongola.
Anche lei lo farà.
Ovviamente decido di salire sulla terza jeep, quella sulla quale Federica ha sistemato con cura le sue chiappe rotanti, invece che sull’ultima, come dovrei.
Dopo nemmeno dieci minuti dalla partenza fa un rumore di catarro e barattoli e si ferma.
Masha, l’autista, blatera qualcosa di irripetibile con la parola “Mungu” e cerca freneticamente qualcosa nel cassettino. È un coltello da cucina col manico di plastica arancione. Scende e apre il cofano. Gli altri mezzi ci sorpassano e proseguono sotto il mio sguardo instupidito. Qualche turista fa il simpatico. Memorizzo la sua faccia. Ha gli occhi da carangide e una ridicola bandana rossa. Mi vendicherò più tardi. Il clan di Federica mi mette alle strette con la loro apprensione. Dico loro che è tutto tranquillo. Scendo e vado a sbirciare dove Masha sta trafficando ma me ne pento mediatamente.
Il motore è una specie di scultura post-moderna fatta di materiali organici e di riciclo. Manicotti realizzati con pelle di zebra e legati con fasci di rafia. I supporti sono in mogano. Una follia. Pura Ingegneria sciamanica! Non voglio che vedano quel delirio. Sorrido e faccio cenno che si risolverà tutto in pochi minuti. Chiedo a Masha se il problema è risolvibile in tempi ragionevoli. Lui mi risponde con l’unica frase in grado di gettarmi nello sconforto e nella paranoia più totale: – Hakuna Matata! – Mentre lo maledico di cuore, un altro fuoristrada si affianca e si offre di aiutarci.
– Fantastico! – bofonchio tra me, sarcastico – Magari questo nella cassetta degli attrezzi ha un mestolo o uno schiacciapatate! – Pare che il guasto sia ad una cinghia la cui funzione mi risulta del tutto ignota. So solo che pare di budello e che sia già stata abbondantemente ricollegata con vistose cuciture. Riusciamo a ripristinare l’avviamento di quella sottospecie di automobile biologica dopo una buona mezzora di armeggiamenti su delle parti scelte a caso e accompagnati da frasi propiziatorie, e grazie anche all’aiuto di Samuel, un tipo del posto che di lavoro fa il vasaio di mattina e il becchino il pomeriggio, a seconda se è il caso di seppellire o cremare la salma.
Attraversato il villaggio di pescatori e dopo una breve sosta davanti il minareto di Mambrui, dove ritroviamo il resto del convoglio già boccheggiante, puntiamo dritti ad un accampamento Mijikenda poco dopo Che-Shale. Il villaggio è composto di sei piccole capanne di fango sparpagliate in una specie di avvallamento circolare circondato da piccole colline e accessibile solo con la bassa marea. Tra un paio d’ore infatti le vie d’accesso saranno completamente sommerse. In tutto una quindicina di anime, un unica famiglia. Vivono in condizioni appena posteriori all’invenzione della ruota, ma sembrano sereni. Ci sono una mezza dozzina di bambini che ci vengono intorno ancora prima di scendere.I palmi delle loro mani perennemente rivolti verso l’alto. In attesa di un qualsiasi oggetto solido da far scomparire. E’ incredibile ma è così. Fateci caso. Mettete una penna o una caramella o anche vostra suocera nella mano di uno di quei marmocchi e vi accorgerete un attimo dopo che lui è ancora lì con la stessa espressione e soprattutto con la mano sempre vuota.
Credo che questo avvenga per smolecolarizzazione extra dimensionale . I turisti abboccano perchè tendono a pensare che sia ogni volta un bimbo diverso. Ma io ormai li conosco. Credo che facciano riapparire tutti questi oggetti (tranne per fortuna vostra suocera) direttamente nel catalogo della Rinascente o in chissà quale remotissimo luogo. Io mi sono riimbattuto nella stessa penna a sfera con la mina verde dopo otto anni su di una bancarella di chincaglieria cinese in piazza Vittorio.
Il capo della tribù è Mbodze, un ciccione seminudo che ci accoglie ,come da contratto,con un macete in mano e l’espressione minacciosa. Un giovane porta dei cocchi da bere e lui li apre con un colpo deciso sull’estremità superiore e li offre a tutti.
I maldiviani li chiamano i kurumba. Mi confondo e li chiamo anche io così: i kurumba ,in africa, invece, sono una popolazione della regione aribinda del Burkina Faso. Ma chi se ne frega! Tanto si bevono ogni vaccata, compresa quella nauseabonda acquetta calda e zuccherosa che fuoriesce da quelle grosse noci verdi.Io sto sempre alla larga da quella brodaglia. E’ come bere l’acqua del termosifone e, tralaltro, provoca un aumento esponenziale della sete fino a trasformarti la lingua in una simpatica pantofola di flanella azzurra.
La penosa processione continua con la visita alla capanna. Peccato dentro sia buio e ci siano solo mosche ad abitarci durante il giorno. Una delle mogli (o figlie, o nonne, o nipoti) di Mbodze, con un bambino in braccio, descrive in un idioma estraneo anche a lei i due minuscoli locali. C’è ben poco da descrivere. Un giaciglio di paglia ammuffita e una buca per cucinare. Entrano uno per volta.
Io rimango fuori appoggiato all’auto a fumare una sportsman con Masha che mi racconta della sorella malata di ulcera.
Vorrei mettermi ad urlare.
La mia frustrazione aumenta.
Quando escono hanno tutti un sorriso di approvazione. Come a dire: – beh…Però, confortevole! – E i piu convinti di quella assurdità sono quasi sempre quelli che vivono in un superattico di fronte il Pantheon o che usano la villetta ad Arzachena solo l’ultimo weekend di settembre e che sono capaci di organizzare un pandemonio di dimensioni bibliche se le tende della loro camera d’albergo non si intonano con l’asciugamano del bidet o con il pigiama della signora.
Ma andate a farvi fottere! La marea intanto sta salendo. Lo si capisce dall’attraversamento frenetico di un paio di famigliole di babbuini che due volte al giorno si trasferiscono da un lato all’altro del villaggio in una sorta di misterioso pendolarismo savanico che scandisce l’ineluttabile consumarsi del tempo e che ci ricorda che dobbiamo allontanarci in fretta. Marea e Babbuini: atavici orologi di una dimensione sempre più estranea a noi individui contemporanei.
Prometto a me stesso che se mi ripesco a filosofeggiare in quel modo idiota mi riduco la mia razione settimanale di ostrichette gratinate al cocco.
Salutiamo i personaggi di quel pittoresco presepe Bantu e ci allontaniamo oltre la collina. Ci dirigiamo a nord in direzione del confine somalo. A pochi chilometri,a Ras Ngomeni, c’è un insediamento italiano, Un centro di ricerca spaziale realizzato a metà degli anni sessanta. E’ possibile scorgere al largo la piattaforma di lancio missilistica “San Marco”. Quì molti ragazzi hanno la pelle chiara e nomi italiani. Anche i nostri accompagnatori. Sono due fratelli e si chiamano Marco e Luigi. Ci attendono sulla riva fangosa del fiume sabaki a torso nudo. Fanno sempre colpo sulle femmine muzungu coi loro fisici perfettamente scolpiti e i lineamenti addolciti da quella combinazione genetica, gentile omaggio della nostra agenzia aerospaziale. Con Marco vado d’accordo e nonostante con i ragazzi locali io comunichi quasi sempre in swahili lui mi parla in italiano. Cosa che accresce tra i suoi compagni un clima di cordiale diffidenza nei miei confronti. Ciò è sicuramente dovuto al fatto che io consegno a lui le commissioni e che le sucessive spartizioni non vengono effettuate tanto equamente. Sospetto, infatti, che Marco si tenga la parte più cospiqua del bottino lasciando le briciole al suo staff mentendo sulla cifra e dando a me la colpa. Perciò io non vengo mai chiamato per nome dai suoi amici, ma solo “huyu” o “rafiki yako”. Ma non me ne frega un cavolo. Non li sopporto un granché per via di quei modi un po’ ambigui e un po’ furbetti, che sono sempre il gentile omaggio del loro sangue italiano.
Il livello dell’acqua intanto si alza rapidamente. Mi tolgo gli anfibi me li butto in spalla e mi infilo i calzini nelle tasche dei bermuda mentre faccio presente a tutti che bisogna camminare in quella melma schifosa fino alla barca, che più che ormeggiata è letteralmente arenata a un centinaio di metri dalla riva. Uno dei momenti di maggior godimento è contemplare con del sano sadismo le espressioni non proprio disinvolte delle signore fresche di lunghi e costosi trattamenti di pedicure pre-vacanza che tentano di nascondere il loro evidentissimo disagio. Perfino Pino, un panciuto impresario teatrale di Milano con il quale ho giocato a scacchi un paio di giorni fa, si rifiuta di entrare in quel lurido acquitrino. Fa molto caldo. Mi innervosisco e sono tentato di azzannargli la giugulare. Faccio prevalere il mio senso diplomatico e mi limito ad insultargli tutto l’albero genealogico. Lo convinco veramente solo dopo averlo minacciato di lasciarlo li con la moglie di Martini, che è una signora affetta da una logorrea tanto trapanante che contemporaneamente alla sua comparsa alcune specie di volatili hanno preferito anticipare la loro migrazione di un paio di mesi.
Saliti sul Dhow prendiamo tutti posto a poppa.
L’equipaggio è composto da quattro scugnizzi. Il più grande, il capitano, avrà 19 anni, l’ età degli altri oscilla tra gli 8 ai 13 e hanno tutti il grado di marinaio/cantante. Aspettiamo qualche minuto che con l’alta marea lo scafo si sollevi dal fondale e finalmente partiamo.
Con molta calma. Il vento è poco.
Il Dhow essendo un’ imbarcazione araba a vela latina, e non un pershing da 4.900 cavalli, ha i suoi tempi.
Lentissimi.
Faccio una panoramica sui volti dei turisti. Sono tutti tirati in quella tipica espressione inebetita che tiene incollati insieme timore ed eccitazione inzuppati di quel senso di grande aspettativa che comunicano gli slogan pubblicitari delle avventure esotiche sui depliants turistici.
Io invece sono impegnato in un ben più serio corpo a corpo con un senso di nausea che mi ha aggredito al colon e che sta avendo sempre più la meglio.
Appena preso un po di vento comincia la lentissima navigazione e in contemporanea anche il festival della canzone africana. Con cucchiai e barattoli vengono ritmate tutte le strampalate musiche del repertorio folkloristico. Si va dalla famosissima Jambo, bwana a classici come karibuni kenya o malaika. Eseguite in coro e senza una benché minima idea di armonizzazione diventano una specie di filastrocche per deficienti. Le facce delle signore che tentano di ripetere quegli ossessivi ritornelli sono permeate da un aurea azzurrognola di pura stupidità. Dopotutto è normale: sono in vacanza!.
Il mio senso di nausea ha un picco insostenibile quando qualcuno, in preda ad un incomprensibile e inopportuno trasporto mistico comincia a battere ritmicamente il tempo con le mani. E’ sempre il tipo con il fazzoletto rosso .
Per fortuna il tragitto è breve e dopo una dozzina di canzoni arriviamo alla salina. Il sole ha raggiunto il punto piu alto. Si scende, attraversiamo a piedi quella lingua di sale, tutti sudati. Dopo qualche foto ai soliti fenicotteri rosa ci addentriamo nella fitta vegetazione circostante: La mitica foresta di mangrovie.
I ragazzi della barca ora stanno tornando a bordo di rudimentali canoe ricavate da tronchi di grossi alberi.Hanno dei lunghi bastoni che usano per gli spostamenti.
Ci saranno si e no 150 cm nei punti più alti.
Non ce n’è una di quelle grottesche barchette che non imbarchi acqua. Riconosco quella con la falla maggiore e la appioppo alla cernia con la bandana rossa. Ci si siede uno dietro l’altro fino a un massimo di cinque girati verso prua tranne l’ultimo che dà le spalle al gondoliere e che, nel nostro caso, è il sottoscritto.
Il barcarolo sta in piedi aggrappato al suo bastone spinge in avanti la canoa e intrattiene gli ospiti cantando brani di Umberto Tozzi e Eros Ramazzotti in uno stentatissimo italiano per il diletto della comitiva che si mostra piacevolmente sorpresa da quell’evento. Io ormai mi sono stampato sul volto una smorfia di dolore che spaccio a tutti come un sorriso. Federica mi sta di fronte e chiede di scattarle delle foto. Poi lei ne scatta un paio a me.
L’avifauna di quella zona è particolarmente nutrita di Ibis, Aironi, Marabù, Cicogne, Egrette e altri stupidi trampolieri. Si vaga per quel fetido pantano con lo sguardo allucinato di chi nutre la speranza che qualcosa di meravigliosamente sorprendente stia per accadere. Nulla! Nemmeno una simpatica comitiva di coccodrilletti affamati di videocamere e di marsupi di Nylon o una bella Anaconda incazzata di una ventina di metri.
Senza apparente meta si girovaga traghettati da un aitante nero caronte attraverso una palude dantesca popolata da insetti, granchi e insulse piante acquatiche. Faccio scendere tutti su un isolotto solo il tempo necessario per illustrare il ciclo vitale di quel fottuto arbusto e per permettere ai barcaroli di svuotare il fondo delle canoe dal liquido marrone che chiamare acqua sembra un fantasioso eufemismo. Mentre rimontiamo nelle canoe concludo tra me che in tutto quel paesaggio selvaggio il panorama più interessante continua ad essere il culo di Federica che si muove sinuoso, dall’interno di un paio di pantaloncini da ciclista ormai tutti inzuppati.
Non si percepisce l’idea dello scorrere del tempo in mezzo a tutto quel silenzio. Questo non fa che accrescere il mio sentimento di insofferenza nei confronti di quel luogo remoto e inospitale.La natura è stata chiara ed esplicita nel suo preciso disegno quando ha deciso di non includere la presenza umana in quel suo progetto! Anzi, tutto pare scrupolosamente studiato a tavolino per tener lontani tutti i non iscritti al club del regno animale. Ora rilevo con sollievo che la nausea ha mollato la presa e ha lasciato il posto ad una fame africana tipica di noi grandi mammiferi della zona. Sarà la vista di quei granchi dall’unica enorme e succulenta chela. Sarà che tra poco saremo seduti di fronte a un piatto di grosse aragoste accompagnate da una bottiglia di freschissimo Sauvignon.
Il ritorno a riva col Dhow si rivela perticolarmente lungo e difficoltoso a causa della totale assenza di vento, tanto che anche se Omero in persona si prendesse la briga di narrarvelo sembrerebbe un balbuziente che tenta di raccontarvi delle barzellette dozzinali.
Nel frattempo, come se non bastasse, l’equipaggio del “Karibuni” si produce in versioni particolarmente estese di quelle insopportabili canzoncine tutto “yeh yeh, jambo jambo! Lalalalala!!” La difficile situazione è resa ancora più irritante dal caldo soffocante, dai moschini, dalla puzza e dall’immagine tremolante delle nostre jeep in lontananza che, in virtù di quel fenomeno chiamato miraggio, assume le sembianze di un sei al superenalotto.
Sono sull’orlo di una crisi nervosa Mi viene quasi da piangere.
Guardo i miei compagni di viaggio e provo un sentimento contrastante di simpatia e tristezza. Il loro concetto di vacanza assomiglia molto a quella di un pellegrinaggio all inclusive alla Madonna di Loreto completo di espiazione mediante pesanti pene corporali.
E’ una forma di eroismo che fa il paio con quello dei loro amici e parenti a casa che sono condannati a sciropparsi i loro racconti nel corso di lunghi ed estenuanti buffet freddi inframezzati da noiosissimi filmini amatoriali e fotografie sfocate di Masaai e babbuini.
Intorno all’una raggiungiamo finalmente la riva e io provo un senso di profondo sollievo nel rivedere il faccione butterato di Masha intento a disperdere, insieme agli altri autisti, un nugolo di bambini più o meno allo stesso modo in cui si allontanano le mosche da un vassoio di tartine imburrate. Finalmente raggiungiamo la spiaggia di Che Shale. Sterminata e deserta. La sabbia a causa della massiccia presenza di pirite ha il colore dell’oro e i raggi solari a quest’ora hanno l’angolazione più propizia per farla apparire come una immensa e splendente lastra dorata. Un effetto incredibilmente suggestivo in grado di rendere questo tratto di oceano indiano uno degli scorci più spettacolari di tutto il globo.
Justin e Marzia ci preparano un pranzetto a base di pesce che da solo varrebbe il prezzo di tutta l’escursione. Lui è un santantonio biondo, figlio di neozelandesi ma nato qui, lei invece, è una ragazza toscana che si dedica, oltre che a cucinare meravigliosamente, a realizzare dei monili che vende nel suo bazaar di Malindi. Il loro ristorantino in stile “naufrago” è incantevole: tutto fatto di legno e makuti. Hanno anche graziosissimi bungalows per un massimo di quattro coppie e una serie di comodissimi lettini prendisole sui quali tutta la comitiva si spalma esausta dopo aver mangiato e bevuto come uno sciame di locuste migratrici. Io e Fede approfittiamo della calda brezza pomeridiana e prendiamo un carro a vela. Ci allontaniamo cavalcando quel grosso triciclo per qualche chilometro correndo silenziosamente nel vento. E’ un trabiccolo veramente divertente da guidare. Per manovrare basta agire coi piedi sulla barra, la velocità è determinata, per mezzo di una scotta, da quanto la randa è cazzata o lascata, per frenare è sufficente puntare la ruota di prua controvento.
Decidiamo di fermarci e di fare un bagno. La spiaggia è tutta nostra.
Comincio a sperare che, avendo placato la collera del Dio delle Mangrovie con del sangue turistico fresco, la seconda parte della giornata possa ripagare almeno in parte le sofferenze e le tribolazioni di quella infernale mattinata.
All’improvviso sento chiappe rotanti lanciare un grido di dolore dietro di me: Qualcosa l’ha punta o morsa a pochi metri dal bagnasciuga. La vedo saltellare urlante su un piede e l’aiuto a sedersi sulla sabbia asciutta. E’ visibilmente spaventata, piagnucola come un cercopiteco orfano e ha il respiro corto e affannato della paura. Cerco di non farla allarmare ma ho il timore che si tratti della puntura di una tèrebra.
P – A – N – I – C – O ! Il veleno della tèrebra è letale e non esiste antidoto come per molte altre specie velenose di quei luoghi.
Dopo aver dato una rapida occhiata al punto interessato, subito sotto l’attaccatura dell’unghia dell’alluce, escludo anche la puntura di un pesce pietra, o di qualche altro scorpenide. Faccio un sospiro e la tranquillizzo.
Decido comunque di succhiarle il sangue per precauzione. Non ci sono aculei ne schegge nel piccolo foro. Nessun gonfiore. Alla fine concludiamo che si sia trattato semplicemente di un oggetto appuntito, (forse il guscio rotto di una conchiglia) oppure di un granchio un po’ stronzo.
Esce dall’apnea e ora mi pare più rilassata.
Continuo a succhiarle l’alluce e a parlarle con un tono rassicurante. – Mmmmmm…Se continui così ti salto addosso! – Mi ammonisce languidamente divertita! Mi metto a ridere e per un po’ non mi strozzo con quel suo ditone in bocca.
Rimaniamo ancora un paio d’ore sulla battigia a cazzeggiare. Ci spalmiamo addosso la sabbia caldissima e le pagliuzze di pirite ci fanno risplendere la pelle.
Decido di fare di lei, sdraiata di schiena, una riproduzione in sabbia a grandezza naturale. Nel frattempo lei si confida e mi parla del suo passato e dei problemi che ha avuto con la cocaina, delle frequentazioni sbagliate al Greenwich Village, di un paio di delusioni d’amore, della separazione dei suoi e dei suoi sogni infranti e di quelli futuri, delle sue paure e del tipo di cereali che preferisce. Parliamo anche di musica, di libri e di pittura, lei è decisamente più per i classici, ma siamo molto in sintonia. E pensare che in altre circostanze non si sarebbe nemmeno accorta di me.
Era facile avere un ascendente così forte nella mia posizione, specie sulle clienti. E io ne approfittavo spudoratamente. Loro erano perfettamente consce del fatto che noi che vivevamo li potevamo offrire molto di piu di un qualsiasi altro compagno di viaggio, anche se esperto del posto, Erano loro a cercare la nostra compagnia e la nostra “protezione” e , dove possibile, anche tutto quello che chiunque altro avrebbe considerato un servizio extra-lusso, praticamente gratis.
Cenette in esclusivissimi ristorantini panoramici, giri panoramici della città, dritte per lo shopping, serate in discoteca, al casinò e lunghe passeggiate romantiche sulla spiagga bianca illuminata dalla luna. Un po’ di buona musica e una bottiglia di champagne avrebbero fatto il resto. Funzionava nove volte su dieci.
Tutto era già notevolmente agevolato dall’atmosfera sensuale del paesaggio africano e dai suoi profumi selvaggi, dai suoi irresistibili richiami a quegli impulsi primordiali che ben predisponevano a mollare i propri freni inibitori fin dall’apertura dei portelli all’aeroporto di Mombasa.
Troppe le condizioni favorevoli in grado di generare tante ottime occasioni per non coglierle.
E io producevo testosterone a quintali.
Rimane colpita da come le mie mani scorrono sul suo fac-simile di sabbia e pirite tanto che finisco per fare il cretino con la scusa di volerle prenderle continuamente le misure e alla fine metto in scena un brechtiano scambio di ruoli cominciando a parlare con la statua di sabbia e levigando e accarezzando l’originale. La scultura è venuta una copia fedele se non fosse per i piedi, che è la prima parte dell’opera che la marea, ormai alta, le sottrae.
Dopo un ultimo rinfrescante tuffo ,decido di invitarla , la sera stessa ,a una tranquilla cenetta sulla terrazzina con vista mare del Mapango, a Watamu. Poi torniamo allo Che Shale Beach Resort , ripartiamo tutti con le jeep e prima di riprendere la via di casa ci fermiamo ad assistere al bagno di una famiglia di timidi ippopotami che quasi ogni tardo pomeriggio si spinge fino alla foce del fiume a fare i gargarismi. Dalla radio del Land Rover , la voce di Smokey Robinson ci sussurra una melodia che si confonde tra il vento e il suono del motore, mentre sullo sfondo di quel tramonto sembrano scorrere, come titoli di coda su un sipario rosso, i versi di Harmonie du Soire: ”…Già s’avvicina l’ora che trepido ogni fiore come un vaso d’incenso svapora sullo stelo; solcano effluvi e musiche la sera senza velo; malinconico valzer, delirante languore! Freme il violino come un cuore afflitto, un cuore tenero che odia il vasto e nero nulla! Il cielo è triste e bello come un repositorio; il sole s’è affogato nel suo sangue coagulato…” (Charles Baudelaire) …Non è così male l’escursione alla foresta di mangrovie…Quando è finita.